 Dopo l’intervallo con i CSI, Angela Baraldi torna in tour in proprio per presentare Tornano sempre (Woodworm /Audioglobe), il primo disco di inediti a suo nome dal 2003. Prodotto da Giorgio Canali (CCCP, CSI) con Vittoria Burattini (Massimo volume, batteria), Stewie Dal Col (chitarra) e la collaborazione di Vincenzo Vasi (theremin), Riccardo DalCol (batteria), Emanuele Reverberi (violino) e Gianni Maroccolo (basso e “atmosfere plananti”). Tornano sempre è disco dal suono teso e asciutto che intercetta lo spirito del tempo. L’essenza del rock, appunto. Abbiamo incontrato Angela Baraldi il 21 aprile a Milano prima del soundcheck al Serraglio, dove ha suonato con Vittoria Burattini (batteria), Beatrice Antolini (tastiere e basso), Raffaele Benevento e Federico Fantuz alle chitarre.
Dopo l’intervallo con i CSI, Angela Baraldi torna in tour in proprio per presentare Tornano sempre (Woodworm /Audioglobe), il primo disco di inediti a suo nome dal 2003. Prodotto da Giorgio Canali (CCCP, CSI) con Vittoria Burattini (Massimo volume, batteria), Stewie Dal Col (chitarra) e la collaborazione di Vincenzo Vasi (theremin), Riccardo DalCol (batteria), Emanuele Reverberi (violino) e Gianni Maroccolo (basso e “atmosfere plananti”). Tornano sempre è disco dal suono teso e asciutto che intercetta lo spirito del tempo. L’essenza del rock, appunto. Abbiamo incontrato Angela Baraldi il 21 aprile a Milano prima del soundcheck al Serraglio, dove ha suonato con Vittoria Burattini (batteria), Beatrice Antolini (tastiere e basso), Raffaele Benevento e Federico Fantuz alle chitarre.
Com’è nato il disco, in che atmosfere?
È stato un disco lavorato in un lasso di tempo piuttosto lungo, perché la prima canzone, Michimaus, che apre il disco, è nata più o meno nel 2011 (http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/michimaus-angela-baraldi-e-ancora-in-viaggio/273536/274070). Ho lavorato un po’ su due piani, nel senso che la musica è stata improvvisata, quindi molto istintiva, direi quasi “buona la prima”. Come arrangiamenti Giorgio Canali, il produttore, non ha voluto metter le mani molto sulla musica, è anche un po’ il suo stile. Quindi mi sono ritrovata con questo materiale che si è accumulato nel tempo, perché nel giro di questi anni abbiamo fatto diverse sessioni, almeno tre o quattro.
In parallelo con lo spettacolo tributo a Ian Curtis dei Joy Division?
Sì, diciamo che il combo, l’idea di fare un disco, è nato con quel progetto sui Joy Division. Ho chiesto a Vittoria di unirsi a questa formazione, quindi ci siamo ritrovati in studio e improvvisando abbiamo registrato tanto materiale. Quello che senti nel disco è una selezione… ho scremato tantissimo. Ci sono anche un paio di episodi dove invece è nato prima il testo, tipo Josephine e Tutti a casa, che è basato su un giro armonico di Giorgio alla chitarra acustica e il cui testo è nato in maniera piuttosto estemporanea.
Come sei entrata in contatto con Canali?
L’ho conosciuto col tributo ai Joy Division. Avevo in testa di fare un disco, perché l’esperienza della serie tv Quo vadis, baby? (prodotta da Sky, trasmessa nel 2008, ndr) mi ha un po’ riaperto la voglia di tornare a cantare, fare qualcosa di nuovo. La volta che ho trovato quest’unione di musicisti che a me piacevano ho detto “dai, continuiamo come abbiamo cominciato riarrangiando i pezzi dei Joy Division, nello stesso spirito”.
Hai scelto tu il gruppo quindi?
Be’, loro si sono proposti, io ho sentito l’esigenza di avere un’altra quota femminile all’interno del disco e ho chiamato Vittoria, anche perché sono tanti anni che ci conosciamo e con lei abbiamo già fatto un disco nel ’96, Baraldi lubrificanti. Io e lei ci assomigliamo un po’, siamo più riflessive, torniamo sopra le cose, mentre sia Steve (Dal Col, chitarrista dei Frigidaire Tango) che Giorgio sono  più istintivi, come nel loro progetto Rossofuoco: improvvisano molto. Ho accettato questo modo di lavorare, anche con curiosità. Ho cominciato a scrivere testi in libertà, poesie vere e proprie, nel senso di libere dalla musica. Dopo di che ho fatto un lavoro di assemblaggio, associando ogni poesia a uno sfondo musicale che mi sembrava adatto. Io le chiamo “poesie”, può sembrare se vuoi una presunzione. Avevo voglia di scrivere in maniera diversa. Mi era capitato in passato di riempire melodie con le parole, invece questa volta ho preferito dare la priorità alle parole e di conseguenza è la melodia che si adatta a queste. Il primo esperimento è stato Michimaus. Quando la riascolto mi sembra quasi un miracolo, perché sembra che in realtà la musica sia stata fatta sulla melodia e invece no, ho adattato la melodia alla musica. Mi ha dato il coraggio di andare avanti. L’album non è nato come un concept, con un’idea programmatica. Anzi, avevo questi pezzi di canzoni nati in molti anni e non pensavo di avere un disco in mano. Giorgio Canali era più lucido, riusciva a vederne il potenziale, mentre io sentivo di star navigando in una cosa molto astratta. Non l’ho visto nella sua interezza finché non abbiamo dato il titolo al disco e fatto la scaletta. Non ti nascondo che in questi quattro, cinque anni ho avuto anche paura di non farcela, perché non sono abituata a lavorare così.
più istintivi, come nel loro progetto Rossofuoco: improvvisano molto. Ho accettato questo modo di lavorare, anche con curiosità. Ho cominciato a scrivere testi in libertà, poesie vere e proprie, nel senso di libere dalla musica. Dopo di che ho fatto un lavoro di assemblaggio, associando ogni poesia a uno sfondo musicale che mi sembrava adatto. Io le chiamo “poesie”, può sembrare se vuoi una presunzione. Avevo voglia di scrivere in maniera diversa. Mi era capitato in passato di riempire melodie con le parole, invece questa volta ho preferito dare la priorità alle parole e di conseguenza è la melodia che si adatta a queste. Il primo esperimento è stato Michimaus. Quando la riascolto mi sembra quasi un miracolo, perché sembra che in realtà la musica sia stata fatta sulla melodia e invece no, ho adattato la melodia alla musica. Mi ha dato il coraggio di andare avanti. L’album non è nato come un concept, con un’idea programmatica. Anzi, avevo questi pezzi di canzoni nati in molti anni e non pensavo di avere un disco in mano. Giorgio Canali era più lucido, riusciva a vederne il potenziale, mentre io sentivo di star navigando in una cosa molto astratta. Non l’ho visto nella sua interezza finché non abbiamo dato il titolo al disco e fatto la scaletta. Non ti nascondo che in questi quattro, cinque anni ho avuto anche paura di non farcela, perché non sono abituata a lavorare così.
È confortante per chi ascolta avere a che fare con questo tipo di qualità, di lavoro fatto con lentezza e profondità…
È un privilegio per me poter ritornare sulle cose dopo tempo, riaprire una traccia, riascoltarla con un orecchio fresco, perché quando sei in studio hai tempi stretti. Cosa che a me serve, perché ho un carattere che tende all’oblio,vado volentieri alla deriva, non mi fa paura. Finché le cose sono sospese sento che posso cambiarle. È una cosa pericolosa che può continuare all’infinito e quando chiudo i pezzi soffro sempre un po’.
In Hollywood Babilonia parli di due stelle cadute (George Reeves, Bobby Driscoll), due loser del cinema. Se vuoi, un cliché abusato. Ma mi pare tu non li citi non perché è bello parlare degli sfigati, farne l’apologia, ma perché c’è un valore, nel fallimento, che va recuperato. È così?
In realtà non c’è stato un pensiero tipo “adesso voglio dire questa cosa”. Sono una lettrice di biografie, mi piacciono moltissimo, e quindi anche Hollywood Babilonia di Kenneth Anger (Adelphi). Sono anche attrice, ho vissuto quel tipo di… transfer psicologico coi personaggi che interpreti, ho avuto un’empatia verso questi personaggi. Mi commuove molto l’idea che questi attori della vecchia Hollywood siano stati i primi ad essere importanti per la gente. La mia è una curiosità umana per la fragilità. Quindi non è così importante poi che siano attori…No, è proprio il meccanismo umano, dell’aspettativa che hanno gli altri verso di te, la paura di deluderli. Anche la figura di Superman la trovo emblematica. George Reeves, il primo attore che lo ha interpretato, si è
suicidato (Ben Affleck lo ha ripreso in Hollywoodland di Allen Coulter, nel 2006, ndr). Questo ha creato grande scoramento nel pubblico, che ha dato un giudizio negativo, nei co nfronti di un atto che tutto sommato è molto estremo ma che io rispetto. Mi piaceva guardare con una lente d’ingrandimento un sentimento proprio umano. Penso che rifletta un po’ la mia persona, la mia ipersensibilità verso certi temi. E questo gusto di farsi il giro in periferia invece che in centro, di visitare la villa che non è ancora stata restaurata, questa sensazione di cose che poi cambieranno e di volerle catturarle prima del cambiamento…
nfronti di un atto che tutto sommato è molto estremo ma che io rispetto. Mi piaceva guardare con una lente d’ingrandimento un sentimento proprio umano. Penso che rifletta un po’ la mia persona, la mia ipersensibilità verso certi temi. E questo gusto di farsi il giro in periferia invece che in centro, di visitare la villa che non è ancora stata restaurata, questa sensazione di cose che poi cambieranno e di volerle catturarle prima del cambiamento…
Nel disco si avverte un senso di disagio diffuso.
C’è una grande richiesta di performance in questo momento storico, anche nel nostro privato. Viviamo delle aspettative e abbiamo un’esposizione del nostro ego molto più spudorata rispetto al passato. Siamo più guardati, guardiamo di più, c’è un aspetto anche voyeuristico che a volte è molto crudele. C’è sempre stato, però adesso è all’apice. È un tema molto delicato, si può cadere in luoghi comuni e allora magari può essere utile andare a ripescare figure in disuso… Per esempio, Josephine Baker (a cui è dedicata l’energica Josephine, ndr) non è una figura perdente, però è comunque un eroe dimenticato, non se n’è mai parlato. Si pensa a questa donna nuda vestita solo di banane ma in realtà la sua è un’immagine di donna molto forte
L’hai scoperta attraverso la sua biografia?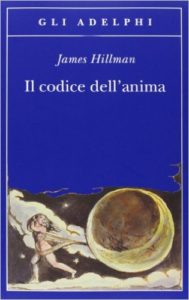
No, leggendo Il codice dell’anima di James Hillman (Adelphi), che parla della capacità di certi personaggi di essere fedeli alla propria gemma, alla propria identità. Lei in questo libro è raccontata come una delle figure più coerenti. Non era più famosa ma ha comunque aiutato in segreto degli ebrei a scappare dalla Francia, ha usato le sue conoscenze per continuare a supportare i diseredati. La trovo una figura molto positiva, non una loser. Semmai è loser la società che si dimentica di persone come lei. Non a caso le magliette che abbiamo stampato per il merchandise hanno la frase “fallire bene, fallire meglio”, che è di Samuel Beckett. Il fallimento come una cosa
nobile, che non significa essere perdenti.
Uomouovo è un po’ l’altra faccia di questo discorso, del tema del provarci anche a rischio di sbagliare.
È la soggettiva ribaltata, di chi si sottrae a questo, per paura anche del fallimento. Di chi preferisce non essere, non lasciare traccia. Uomouovo è l’uomo senza lineamenti, l’indifferenza che in ogni era si ripropone sempre uguale, il non partecipare. Anch’io ho avuto paura di essere “uomouovo” in certi momenti, perché è per gli ipersensibili è facile rinchiudersi nella propria dimensione. Poi mentre scrivevo ho capito che invece di parlare additando, dovevo mettermi in soggettiva, raccontare dal punto di vista di chi vive così.
In Tornano sempre c’è una continuità, un suono rock, non volutamente sporco ma piuttosto calibrato.
Devo dire che c’è stato un lavoro tra la mia visione e quella di Canali, che è più ruvida, più “no, non tocchiamo più niente”. Ho un po’ lottato per ritornare sopra certi passaggi. Perché ci sono delle delicatezze in questo disco che ho difeso tantissimo, anche nel modo di cantare. L’unica cosa che avevo chiara in testa era quella di voler sussurrare, cantare all’orecchio dell’ascoltatore a
una distanza ravvicinata. Ho scritto queste canzoni mentre stavo cantando molto i pezzi dei CCCP e CSI, dove declamavo molto perché lo richiedevano le canzoni stesse. Qui avevo invece il bisogno di dire una verità in maniera più intima. È un disco crudele, tutto sommato, nei testi. Non c’è una soluzione a lieto fine, mai. E questo secondo me gli dà carattere, gli dà verità.

Tra i dieci pezzi ce n’è uno solo che non hai scritto tu: Sono felice.
È un brano inedito, scritto da nel 2000, Michele Stefani in arte Macromeo, un writer bolognese che ai tempi era un adolescente. Poi ci sono state le Torri Gemelle e lui ha avuto il pudore di non parlare di esplosioni, non ha avuto il coraggio di farla uscire. L’ho trovata geniale. Anche questa è una canzone in soggettiva, vista dalla parte di chi sta vivendo quel tipo di sentimento, adolescenziale e di grande disagio.
A me sembrava il punto di vista di chi è sotto psicofarmaci.
Ci può stare. Il disco per me comincia ad assumere un’identità adesso, perché mentre lo stavo facendo non capivo niente. Ho conosciuto autori di canzoni di successo, come Lucio Dalla, che invece scrivevano con una consapevolezza maggiore dell’interlocutore. Ecco, io questo problema non
me lo sono posto, la visione di chi ascolta non mi appartiene. Lucio, quando scrive, pensa alla gente. Io no. Ma perché sono forse più fragile e mi interessava trasmettere questo disorientamento, questa fragilità, questo mistero, anche.
Ci sarà un tour di Tornano sempre?
Voglio fare tanto live, ma non è facilissimo, con un disco così poco da intrattenimento. Un problema che mi sono posta molto in questi anni è “come farò a cantare così piano, a essere così confidenziale?”. Quando ho cantato le canzoni dei CCCP e dei CSI avevo davanti un pubblico molto vasto, mi dicevo “se cantassi Michimaus, tutta sta gente cosa penserebbe?”. Ma alla fine credo che il veicolo più potente sia quello della sincerità, dell’autenticità. Quando ho cominciato a cantarle dal vivo ho capito che andava bene così, che era un problema che mi facevo io, una paranoia tipica di chi sta nella sua cameretta a scrivere. Avrei voluto che il disco uscisse prima dell’inverno, perché immaginavo piccoli club, situazioni di intimità. Poi c’è stato un ritardo, è uscito a fine febbraio, quindi adesso mi dovrò confrontare con un pubblico estivo. Però mi va bene anche essere outsider in questo. Penso che alla fine sia un disco che si cercherà il suo pubblico.
Tutti a casa è dedicata a Federico Aldrovandi…
È stata scritta pochi giorni prima della serata concerto a lui dedicata, che si tiene a Ferrara tutti gli anni a settembre. Quando mi hanno invitata a cantare non era ancora stata registrata. Cantandola ho sentito da parte del pubblico un’onda di comprensione e ho capito che volevo dedicarla a lui. Il titolo riprende quello del film di Comencini che mi sembra abbia a che fare con i temi del disco: la resa, in tempi di disagio sociale, e insieme una voglia di resistenza non subita, ma agita.
A proposito di questo, riprenderai a fare cinema?
Per me il cinema è stato un felice incidente di percorso. Mi sono magicamente trovata a fare un ruolo importante per un regista come Salvatores senza volerlo. Sono stata cercata da lui e questa cosa mi è sembrata molto magica, perché ho studiato recitazione, ho fatto l’Accademia d’Arte Drammatica, era nei miei sogni di adolescente, insieme alla musica. Desideravo di poter avere un ruolo importante e questa cosa si è avverata. Finita la serie Quo Vadis, Baby? mi sono chiesta se  restare a Roma o andare a Bologna. Rimanere a Roma avrebbe voluto dire rinunciare a quella che è la mia parte musicale; non ci sarebbe stata tutta questa parentesi di concerti dal vivo che, nella mia storia credo mi erano dovuti: i dischi che ho fatto negli anni ’90 non li ho mai suonati abbastanza dal vivo. Mi confrontai anche con Salvatores su questo e lui mi disse che prevedeva un momento di grande crisi del cinema e mi consigliò di tornare a Bologna. Prima almeno a Roma c’erano le feste dove andare per conoscere il produttore, adesso manco quelle… Ho fatto diversi provini ma succede che quando riesci in un personaggio, ti viene continuamente riproposto quel ruolo.Trovo questa cosa un po’ limitante e faticosa. Inoltre non sono tante le parti per le donne sopra i quaranta e l’esperienza in sé mi sembrava già esaurita. Poi è chiaro che c’è una parte narcisista che vorrebbe ripetere la cosa, perché comunque il cinema è magico.
restare a Roma o andare a Bologna. Rimanere a Roma avrebbe voluto dire rinunciare a quella che è la mia parte musicale; non ci sarebbe stata tutta questa parentesi di concerti dal vivo che, nella mia storia credo mi erano dovuti: i dischi che ho fatto negli anni ’90 non li ho mai suonati abbastanza dal vivo. Mi confrontai anche con Salvatores su questo e lui mi disse che prevedeva un momento di grande crisi del cinema e mi consigliò di tornare a Bologna. Prima almeno a Roma c’erano le feste dove andare per conoscere il produttore, adesso manco quelle… Ho fatto diversi provini ma succede che quando riesci in un personaggio, ti viene continuamente riproposto quel ruolo.Trovo questa cosa un po’ limitante e faticosa. Inoltre non sono tante le parti per le donne sopra i quaranta e l’esperienza in sé mi sembrava già esaurita. Poi è chiaro che c’è una parte narcisista che vorrebbe ripetere la cosa, perché comunque il cinema è magico.
Hai mai pensato di sviluppare un’idea tua per il cinema?
Ho avuto più volte la tentazione di scrivere una sceneggiatura, proprio perché amo leggere le biografie. Per la regia invece penso ci voglia molta esperienza, molta scuola. Ho trovato quella del cinema un’esperienza particolare, non ti nascondo che ho avuto anche degli incubi. Sognavo spesso questa cinepresa che mi correva dietro, questo macchinone nero che mi inseguiva, dal quale cercavo di ripararmi. Anche nella serie tv, lavoravo tutto il giorno, ero sempre sul pezzo, non c’era mai un attimo di tregua. Il vero lato faticoso per un attore è quando ti mettono da parte e devi aspettare il tuo momento. Quello per me è il vero dramma. Trovo che la condizione dell’attore sia più penosa rispetto a quella del musicista. Per me è stato molto liberatorio rimettermi a scrivere, avere una zona mia di autogestione. Un musicista dice “adesso scrivo un pezzo”; l’attore, se non ha un regista, un produttore, un progetto, è un sacchettino vuoto. È anche questo aspetto che mi ha portato a scrivere Hollywood Babilonia, perché la gente non lo considera. Un attore lo vedi solo in azione, non nei momenti di pausa, o quando è a casa, mentre aspetta la chiamata. Hai una visione parziale della sua vita, secondo me molto faticosa. Nel cinema ancora più che nel teatro, che ti porta tutte le sere a confrontarti con un pubblico. È duro, rigoroso, non puoi assolutamente lasciarti andare ai tuoi vizi, alle tue cose. Io posso bere un bicchiere di vino, salire sul palco e sfogare la mia rabbia, il mio sentimento e condividerlo. L’attore non può fare questo, deve nascondere il suo privato, dimenticarlo. Può essere un gioco interessante ma alla lunga lo paghi salato, perché sei sempre qualcun altro. Enel momento in cui questo personaggio si esaurisce, sei una cellula dormiente, in aspettativa di un provino. I provini sono tremendi, delle torture, orribili, in questi luoghi che non decidi tu, che possono essere uffici, studi…
Torniamo alla musica. Rispetto al momento in cui hai esordito, come ti trovi oggi?
La discografia è molto cambiata ma mi assomiglia di più questa dimensione che quella di prima. Ho sentito un’intervista bellissima a Fellini, in cui gli veniva chiesto come nasce un film. Lui rispondeva: “firmo un contratto, mi danno una scadenza…”. Questa cosa è molto vera e mi ha liberato da un senso di colpa perché quando ero con le major, effettivamente, se non avessi avuto delle scadenze, i dischi forse non li avrei fatti. Anche l’urgenza ha una sua funzione psicologica. Infatti, durante la lavorazione di questo disco, dove invece la scadenza non c’era, ho provato dei momenti di vertigine, perché ero abituata a una cosa blindata, che si doveva chiudere entro un dato tempo. Però, al tempo stesso, la qualità – certo, io non sono Fellini – può essere minore, perché comunque devi stare dentro a una grata. In questo caso ho provato molte vertigini ma il risultato mi assomiglia di più. Sono stata forse unpo’ viziata per quello che riguardava l’organizzazione. Adesso mi ritrovo ad essere anche un po’ discografica di me stessa, a pensare a tutte le cose, il gruppo, il viaggio, il furgone… son cose che non ero abituata ad affrontare e che hanno una poetica, insomma… relativa.
Nelle note di produzione del disco si legge “Angela Baraldi, voce chitarra tastiere e pluripolarismo”. Cosa vuol dire?
Le ha scritte Canali… Pluripolarismo vuol dire che prima ero bipolare, poi tripolare, dopo quadripolare… Come dice il testo di Michimaus, “scusa la fantasia, i cambiamenti d’umore” perché lì ci sta il mio carattere, un po’… diciamo… insomma, hai capito.
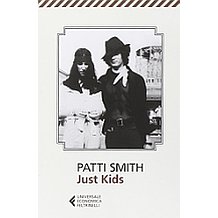 Quest’anno Patti Smith viene premiata dall’Università di Parma con una laurea ad honorem e due mostre. Cosa pensi di questi eventi un po’ istituzionali?
Quest’anno Patti Smith viene premiata dall’Università di Parma con una laurea ad honorem e due mostre. Cosa pensi di questi eventi un po’ istituzionali?
Proprio a Parma, il 3 maggio, farò un concerto a lei dedicato, insieme all’attrice Angela Malfitano, che leggerà degli estratti da Just Kids (Feltrinelli). Mi piace l’idea, perché lei lo merita, cazzo, trovo che sia bello. Mi fa anche specie, perché quando ero ragazzina e ascoltavo Patti Smith – e l’ho anche vista a Bologna, al famoso concerto allo stadio — mi sembrava una scoperta tutta mia… il fatto che adesso sia diventata una figura istituzionalizzata… però è bello. Lei è sempre stata per me un punto di riferimento perché unisce la spiritualità al punk, un connubio abbastanza raro, molto femmineo, se vuoi. Mi piacciono anche i suoi strani fanatismi religiosi, che trovo così fuori scala, così inadeguati e che allo stesso tempo fanno attrito con il personaggio. Ho molto presente il momento in cui a Bologna cantò la canzone dedicata al Papa: aveva una folla adorante, che in quel momento le si è rivoltata contro; hanno cominciato a strappare zolle di terra dal campo da calcio e a tirargliele per tutta la durata della canzone, che lei comunque ha portato a termine, come una specie di guerriero. Poi, finita la canzone, tutti di nuovo ad adorarla. E allora mi dicevo nella mia ingenuità: “ma questi non hanno comprato il disco? Ma non lo sapevano che c’era questa canzone? Perché la trattano così male?”. Trovo che questi personaggi, apparentemente incoerenti, ma che non sono stati domati dalle case discografiche, abbiano una loro forza. Mi ricordo che con la mia casa discografica avevo dei problemi, perché cambiavo tipo di voce a seconda della canzone che cantavo. A loro questo sembrava molto sbagliato, invece per me era una qualità. Avevano sempre bisogno di un punto di riferimento, tipo “no, ma Loredana Berté fa così…”. Ecco, questo è il limite della discografia, soprattutto italiana. Volevo mettere le chitarre elettriche nel mio primo disco e non c’è stato verso di convincerli; poi lo ha fatto Alanis Morissette e da quel momento bisognava per forza metterle. C’era sempre bisogno di qualcuno che aprisse la strada, e lo trovavo molto poco avventuroso. I salti nel buio hanno la loro poesia.
E torniamo al tema dominante di Tornano sempre.
Sì, il salto nel buio, l’incertezza, la non garanzia. Di sicuro il muovermi in un ambiente diciamo alternativo, chiamalo come vuoi, mi assomiglia di più. Quando penso alla mia storia mi sembra un po’ di aver fatto il percorso all’inverso. Cioè, sono entrata dentro le major trovando porte spalancate e adesso sono con le etichette indipendenti. Mi piace l’idea di diventare piano piano una principiante. In senso positivo, perché il principiante ha la purezza. È quello che porta l’odore della sua stanzetta, che poi piano piano col procedere della carriera si dilegua nel professionismo. Io ho fatto forse il percorso inverso perché sono alla ricerca di una verità nella quale sentirmi a mio agio.

Immobili dice tanto del nostro rapporto con la guerra, l’immigrazione, la loro comunicazione mediatica.
Michimaus e Immobili, che aprono e chiudono il disco, sono i primi due pezzi che ho spedito a Giorgio come esperimenti di testo sulle nostre improvvisazioni. Immobili l’ho scritto guardando Rai Storia, davanti all’immagine di gente in fila per un pezzo di pane. Poi mi sono detta: “ma che cazzona che sono, che scrivo le canzoni guardando la tv!”. Ed è successa questa roba incredibile: nel ’93 avevo cantato con De Gregori Anidride solforosa, dal vivo, che poi è andata a finire in un suo disco (Bootleg, 1994). E sempre guardando Rai Storia, che mi piace tantissimo, ho visto un documentario, mi sembra del ’75, sui giovani italiani che andavano in India, diciamo i primi fricchettoni. Intervistano questa ragazza, a cui chiedono: “come mai sei partita per l’India?”. Lei risponde: “sono andata via perché rimanere sempre a Faenza non è che mi interessasse troppo”. Sono andata a vedere di che anno fosse quel documentario e la data d’uscita di quella canzone. Così ho capito che Roberto Roversi, autore del testo, aveva visto quel documentario e ha usato come attacco di Anidride solforosa la frase di quella ragazza, che faceva anche ridere, perché il suo forte accento romagnolo in quel contesto molto esotico. Quindi le fonti di ispirazione possono essere le più svariate, non c’è nessun tipo di pudore, anche una pubblicità televisiva può esserlo.
E tu con Immobili, che chiude il disco, racconti il nostro presente.
Ho cercato di scrivere cose che possano andare bene sempre, come i completini di Chanel. Non c’è un giudizio. “Non fa nessun rumore” perché i testimoni che sono sotto terra non possono più raccontare quello che è successo. Noi continuiamo a parlare della guerra nello stesso modo e la guerra continua a esserci. Non è che siccome non c’è nel mio Paese allora non esiste. Volevo dire questo.
(Grazie a Franco Capacchione)


