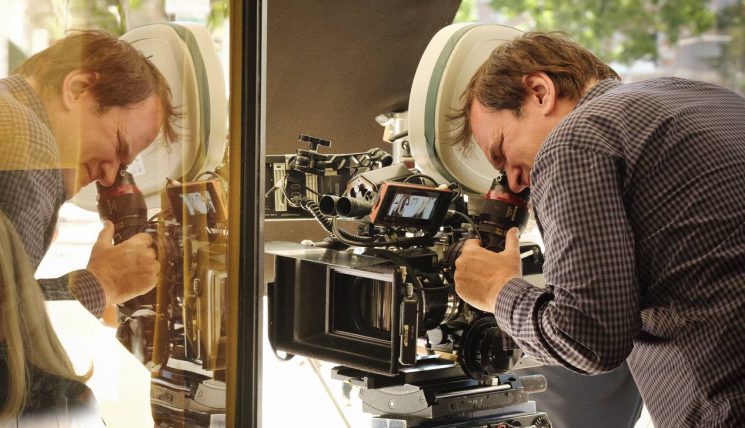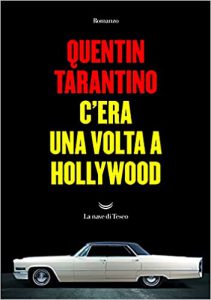 Una certa tensione a moltiplicare le sue storie, Quentin Tarantino l’ha sempre avuta: basti pensare a The Hateful Eight convertito in miniserie tv, al fumetto Django/Zorro, al sempre promesso sequel di Kill Bill e al mai realizzato spin-off di Pulp Fiction (The Vega Brothers). In questa vertigine di “doppi”, il romanzo di C’era una volta a Hollywood (La nave di Teseo, pag.400, euro 19) gioca un ruolo particolare, pur considerando quanto l’autore non sia un novizio delle librerie, che da sempre ospitano le sceneggiature dei suoi film (da noi pubblicate quasi tutte da Bompiani). Lo scritto dell’autore americano si pone infatti quale autentica elevazione a potenza del concetto: la storia in cui cinema e società americane affrontano il giro di boa dei Sessanta si fa infatti testo rinnovato. Affiorano nuovi dettagli, prospettive diverse sui personaggi e il loro vissuto, digressioni di vario tipo in un approccio a tutto campo che esplora anche il prima e il dopo dei fatti già vissuti sullo schermo. Cosa succede in seguito al celeberrimo finale “ucronico” lo troviamo ad esempio fra queste pagine e a nemmeno un terzo dello svolgimento. Quel finale lì, per la cronaca, diventa anzi una sorta di nota a margine: non ne viene esaltato il potere drammaturgico, la portata salvifica rispetto al suo tempo e, anzi, il leitmotiv dello scontro con la Family mansoniana resta un elemento quasi di sfondo in tutta la storia. Nell’epoca in cui tutto deve essere espanso, infinito, allungato per “dire di più” ed esacerbare la narrazione cinematografica, insomma, Tarantino usa la stessa modalità per creare qualcosa di diverso.
Una certa tensione a moltiplicare le sue storie, Quentin Tarantino l’ha sempre avuta: basti pensare a The Hateful Eight convertito in miniserie tv, al fumetto Django/Zorro, al sempre promesso sequel di Kill Bill e al mai realizzato spin-off di Pulp Fiction (The Vega Brothers). In questa vertigine di “doppi”, il romanzo di C’era una volta a Hollywood (La nave di Teseo, pag.400, euro 19) gioca un ruolo particolare, pur considerando quanto l’autore non sia un novizio delle librerie, che da sempre ospitano le sceneggiature dei suoi film (da noi pubblicate quasi tutte da Bompiani). Lo scritto dell’autore americano si pone infatti quale autentica elevazione a potenza del concetto: la storia in cui cinema e società americane affrontano il giro di boa dei Sessanta si fa infatti testo rinnovato. Affiorano nuovi dettagli, prospettive diverse sui personaggi e il loro vissuto, digressioni di vario tipo in un approccio a tutto campo che esplora anche il prima e il dopo dei fatti già vissuti sullo schermo. Cosa succede in seguito al celeberrimo finale “ucronico” lo troviamo ad esempio fra queste pagine e a nemmeno un terzo dello svolgimento. Quel finale lì, per la cronaca, diventa anzi una sorta di nota a margine: non ne viene esaltato il potere drammaturgico, la portata salvifica rispetto al suo tempo e, anzi, il leitmotiv dello scontro con la Family mansoniana resta un elemento quasi di sfondo in tutta la storia. Nell’epoca in cui tutto deve essere espanso, infinito, allungato per “dire di più” ed esacerbare la narrazione cinematografica, insomma, Tarantino usa la stessa modalità per creare qualcosa di diverso.

Di qui la portata geniale dell’operazione: il modo in cui Tarantino è consapevole che cinema e letteratura sono linguaggi diversi, non direttamente sovrapponibili ma paralleli. Andatelo a dire a chi lamenta ogni cambiamento della fonte quando esce una trasposizione. Tarantino non ascolta e va per la sua strada e utilizza questo scarto come opportunità, consapevole com’è che la forma scritta può permettersi una episodicità virtuosa, in cui la storia si slega dalle regole della drammaturgia per farsi testo libero. Così, niente vicenda divisa in tre giorni “pescati” nella vita dei protagonisti, ma un andamento non lineare, in perenne bilico tra passato e presente, dove l’intreccio si assottiglia in mille rivoli sparsi. Il 1969 dalla penna di Tarantino diventa così un mosaico che tiene sullo stesso piano cinema e televisione, ma soprattutto è incredibilmente arricchito e complicato da una perenne ambiguità di fondo: c’è Rick Dalton che snobba quel mercato del piccolo schermo in cui opera perché sogna in grande, anche se, in fondo, tutta la sua fortuna deriva da lì e proprio su di lui si consuma forse l’unico accenno di story-arc più definito. C’è Sharon Tate che è qualcosa in più del simbolo di innocenza infranta dall’orrore del reale, è anche una donna arrivata nella grande città affrontando un viaggio coraggioso, consapevole di dover recitare la parte della “bambolina” e che porta avanti la sua relazione con Roman Polanski tra numerose piccole divergenze di opinioni. E c’è soprattutto Cliff Booth, che in un certo qual modo sembra perdere la purezza dello sguardo di Brad Pitt per diventare un uxoricida conclamato che l’ha fatta franca, un cinefilo sprezzante e un menefreghista baldanzoso da cui si resta anche parecchio turbati. Il fascino del ritratto cede così il passo a tratti a un forte spiazzamento per questo mondo che, in totale controtendenza rispetto al nostro presente, ostenta un machismo esasperato.

Un pianeta-cinema che non vuole porsi quale percorso di redenzione per le storture del sistema hollywoodiano perché esse sono parte della sua storia, all’interno di un’America dove lo spettacolo e la tragedia del reale si intrecciano a doppio filo: come con quel Charles Manson che baratterebbe volentieri la sua comune per un contratto discografico. Se la lettura è vorace, irresistibile e ricca di dettagli come ci si aspetta naturalmente da un cinefilo onnivoro quale è Tarantino, la sensazione è dunque quella di rispecchiarsi in un libro che esprime l’intimo segreto di ogni racconto: funzionare nell’essenzialità data dall’eliminazione del superfluo, ma restare sempre aperto a nuove possibilità ogni qual volta quel “di più” torna alla luce a interrogarlo. Un intrigante what if, insomma, o forse un binario parallelo, un doppio appunto. Così come è perfettamente “doppio” il formato della novelization cui l’operazione ammicca con consapevolezza. Tarantino ha fatto le cose per bene, l’edizione americana è in un “classico” formato paperback e presenta alcune false pubblicità di novelization parallele. Un aspetto, quest’ultimo, purtroppo eliminato dall’edizione italiana, che si presenta in ogni caso elegante e maneggevole nella confezione, secondo gli standard tipici de La nave di Teseo e con un’ottima e scorrevole traduzione a cura di Alberto Pezzotta, che tiene testa con competenza ai ritmi tarantiniani. E scusate se è poco.