
Nella sigla di Willy, il Principe di Bel-Air, Will Smith canta l’antefatto della serie palleggiando sul playground di “West Philadelphia”. L’identità afroamericana del protagonista è definita nella prima strofa (della versione originale) e da quello spazio urbano in cui si gioca ancora la migliore chance per i giovani afroamericani di uscire dai confini del ghetto. Lost in translation, gli autori italiani crescono Willy tra “un canestro e un film di Spike Lee”, il playground illustra magnificamente il fenomeno di trasposizione di un’identità a un luogo. È sul suo asfalto che cresce una cultura alternativa a quella bianca dominante e si canalizzano le energie intorno a uno sport tradizionalmente bianco e tipicamente americano. Il basket nasce nel 1819 a Springfield, Massachusetts, dall’immaginazione di James Naismith per occupare gli studenti duranti i lunghi inverni. Diventato rapidamente popolare nelle zone urbanizzate del Paese, si pratica principalmente nella Young Men’s Christian Association (YMCA) ma grazie alla volontà dei suoi direttori sportivi, il basket esce dai college e dalle università e trova nel playground un palcoscenico più accessibile. Un geosimbolo e un luogo di ricreazione straordinario che contribuisce alla costruzione di identità urbane. Propagata per mimetismo, migrazione o per il dislocamento dei direttori sportivi della YMCA, la pratica del basket, diversamente dal baseball e dal football, richiede un investimento finanziario modesto, sia per l’equipaggiamento del giocatore che per le infrastrutture sportive. I campi di gioco a cielo aperto cominciano a svilupparsi nel 1880 e alla fine degli anni Venti del secolo successivo, il numero di playground nelle città americane sale a 10.000. A differenza degli stadi, questi spazi sono finanziati dalle autorità municipali e permettono un’attività amatoriale su un terreno più aspro del parquet ma non meno appassionante. Sulla strada crescono i giocatori di domani e pescano i futuri talenti gli agenti delle squadre professioniste. Nell’immagine d’apertura Foster Park a Chicago.

In un Paese che predica il superamento di sé e il culto del successo, gli atleti più dotati diventano presto veri e propri eroi. Così se il principe di Will Smith ripara a Bel-Air nel salotto di uno zio facoltoso, i suoi bro provano a guadagnarsi il titolo sul playground, the great way out of the ghetto. Il basket, fatto sociale totale, diventa un fatto personale totale. I tempi sono maturi e nella seconda metà del Ventesimo secolo il basket conosce un’apertura etnica passando da gioco praticato essenzialmente dai bianchi a sport praticato soprattutto dagli afroamericani. L’accesso massivo dei white ethnics alla classe media ‘ricambia’ le nicchie sociali, aggiornando la competizione e la predazione di una risorsa comune. Gli afroamericani, che subiscono più di tutti le cattive condizioni socio-economiche, abbracciano il basket per le stesse ragioni dei white ethnics prima di loro: far progredire la razza (uplifting the race). Progressivamente i giocatori del ghetto impongono la loro cifra di gioco. Uno stile nero dinamico e provocatore nasce sui playground urbani e trasloca in NBA, dove gli afroamericani debuttano nel 1950 volgendo al nero la league professionista. In opposizione agli altri, la maniera black permette la costruzione di un’identità collettiva e di un sentimento di appartenenza, dispiega una rivoluzione stilistica che non riguarda solamente il gioco ma la maniera di essere, di abbigliarsi, di parlare, di fare qualcosa. Il basket sta allo sport come il jazz alla musica, un ritmo nuovo fondato sull’improvvisazione che rimbalza il tirocinio minuzioso e dogmatico e privilegia un’ispirazione più spontaneamente creatrice. La qualità di quella improvvisazione segna lo scarto tra i classroom players, che praticano un gioco appreso sui libri di scuola, e gli streetball players che vivono (letteralmente) il gioco sulla strada. Col tempo questa distinzione volge in luogo comune, celebrando l’improvvisazione istintiva, passando sotto silenzio il lavoro necessario alla base di ogni creazione, alimentando l’opposizione tra giocatori neri ribelli e giocatori bianchi conformisti e finendo per cavalcare le categorie tipiche delle distinzioni razziali con arabeschi e sofismi.

Nello sport come nella musica, il genio naturale degli afroamericani li renderebbe (per esempio) irriducibilmente refrattari alle regole socialmente ammesse, conclamando un’attitudine in-your-face intraducibile o quasi. Una maniera di fare o di mostrare nel raggiungimento dei propri obiettivi una sfrontatezza robusta, che se ne frega del mondo e di quello che pensa di noi. La stilizzazione di questa ‘vocazione’, secondo Davis W. Houck, professore alla Florida State University, è lo slam dunk (schiacciata), reso celebre dai giocatori neri e diventato cifra del gioco dei playground. Violenza e bellezza partecipano all’estetica di un gesto tecnico che definisce l’identità e la mascolinità dei neri americani degli anni Sessanta e Settanta in lotta contro la dominazione, l’exploitation, l’umiliazione. La veemenza è rintracciabile nella relazione con l’avversario, umiliato e ‘schiacciato’ dal giocatore attaccante che colpisce rabbiosamente il ferro del canestro. Più che guadagnare punti, l’azione spettacolare vuole avvilire l’avversario con un’orgia di potenza fisica, elevando il gioco al di sopra dell’antagonista, naturalmente bianco. L’aggressività sottesa si accompagna a un modus cool, a una nonchalance e a un distacco che traduce una strategia di sopravvivenza in una società di esclusione e di oppressione. Dal 1984 la popolare schiacciata ha guadagnato uno statuto artistico nei multipli concorsi che la esaltano, il più celebre è lo “Slam Dunk Contest”, organizzato ogni anno dall’NBA, che capitalizza il sentimento di nostalgia di un gioco e di un luogo che ha conosciuto negli anni una trasformazione geografica, urbana ma anche e soprattutto culturale.

Se ad Harlem il processo di gentrificazione, legato sempre all’intrusione e alla commercializzazione del territorio, ha messo in pericolo l’identità del playground e della sua funzione in seno alla comunità, scavando un fossato tra le radici educativi e culturali e il suo nuovo destino di successo commerciale alla moda, nel South Side di Chicago la violenza e le frequenti sparatorie stanno uccidendo il gioco più bello del mondo. Da questa parte dell’oceano il basket è sempre stato lo sport di due stagioni: l’inverno e l’estate. L’inverno fa i soldi (NBA), l’estate fiorisce le leggende di strada. E Chicago ne rivendica tante. I suoni del basket sono il battito cardiaco di questa città. Palle che rimbalzano e ragionamenti animati risvegliano un gioco che risorge sull’asfalto col sole. Ma da qualche tempo sui playground di Chicago è sceso un silenzio sinistro, insopportabile. I campi, soprattutto quello di Jackson Park, in cui è cresciuto Barack Obama, sono vuoti, disertati dai ragazzini. Non sono i videogiochi o le attività extracurricolari alternative a chiamarli fuori ma i trafficanti di droga e le gang rivali che si sparano addosso senza curarsi di colpire il prossimo Derrick Rose. Il playground è diventato il loro campo di gioco, un gioco che uccide due persone al giorno. I 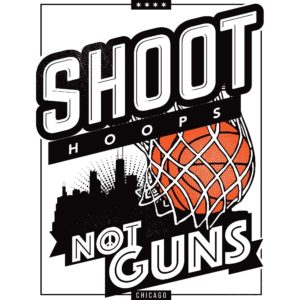 conflitti a fuoco interessano soprattutto il sud e l’ovest della città, zone prevalentemente nere, che non è possibile raggiungere nemmeno per uno scatto o una testimonianza. L’estate è finita in quell’angolo magico di Chicago in cui arriva troppo tardi il grido di allarme (“Shoot Hoops, not Guns”) di Michael Jordan, Derrick Rose, Jimmy Butler (appena venduto ai Minnesota Timberwolves) e dell’ex presidente Obama, tutti e quattro profondamente legati alla cultura del basket a Chicago. Oscurato il gioco, Foster Park resta l’ultimo baluardo in piedi contro i proiettili e l’idiozia. Un avamposto bianco agli antipodi di Jackson Park, troppo lontano per i bambini neri di South Side a cui hanno rubato il sogno e lasciato una sola opzione: trovare un campo o morire cercandolo. La chance (ben giocata) di integrazione si rovescia in pericolosa illusione, bruciando uno spazio sociale di creatività culturale e di riconoscimento simbolico, di resistenza politica e di rivendicazione civica, di ideologia stilistica e di politica del corpo. A vincere ancora una volta sono una società strutturata dal razzismo e una squadra di bulli, quelli ‘fuggiti’ da Will Smith: “when a couple of guys they were up to no good, started making trouble in my neighborhood”.
conflitti a fuoco interessano soprattutto il sud e l’ovest della città, zone prevalentemente nere, che non è possibile raggiungere nemmeno per uno scatto o una testimonianza. L’estate è finita in quell’angolo magico di Chicago in cui arriva troppo tardi il grido di allarme (“Shoot Hoops, not Guns”) di Michael Jordan, Derrick Rose, Jimmy Butler (appena venduto ai Minnesota Timberwolves) e dell’ex presidente Obama, tutti e quattro profondamente legati alla cultura del basket a Chicago. Oscurato il gioco, Foster Park resta l’ultimo baluardo in piedi contro i proiettili e l’idiozia. Un avamposto bianco agli antipodi di Jackson Park, troppo lontano per i bambini neri di South Side a cui hanno rubato il sogno e lasciato una sola opzione: trovare un campo o morire cercandolo. La chance (ben giocata) di integrazione si rovescia in pericolosa illusione, bruciando uno spazio sociale di creatività culturale e di riconoscimento simbolico, di resistenza politica e di rivendicazione civica, di ideologia stilistica e di politica del corpo. A vincere ancora una volta sono una società strutturata dal razzismo e una squadra di bulli, quelli ‘fuggiti’ da Will Smith: “when a couple of guys they were up to no good, started making trouble in my neighborhood”.



