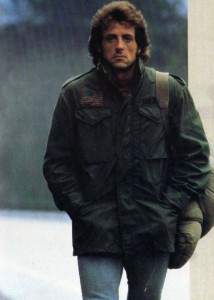 Un cognome può essere più forte di un nome. Nessuno, per esempio, mi ha mai chiamato Gardenzio, sapete. E Sylvester è lunghetto per gli standard americani. E poi ricorda il gatto del canarino Titti. Quindi mi è toccato Sly tutta la vita, che va anche bene. Ma il cognome, dicevo, quello di papà “barbiere di Sicilia” di Broccolino da film dei vostri Franchi e Ingrassia, quello stava per fregarmi. Lo “Stallone Italiano”. Alé. Io sto messo bene là sotto, sapete? Vi ricordate quando Ciak pubblicò la mia foto di come mamma mi fece? Ecco. Il mio esordio davanti alla macchina da presa. The Party at Kitty and Stud’s (in Italia lo trovate in dvd come Italian Stallion/Porno proibito – un’esagerazione, era solo una cosina soft, ma appunto). Avevo 24 anni ed ero povero in canna, che volete farci. Avevo pure lasciato il college, per andare a New York a fare l’attore. Ma soft o porno che fosse, sapevo già che non sarei mai voluto diventare un altro Johnny Wadd, anche se insomma, avessi voluto dargli del filo da torcere, me la sarei cavata piuttosto bene. Era il 1970. E subito dopo feci un altro film, ma le mie scene furono eliminate al montaggio. E ci provarono, comunque, a lanciarmi: prima vestito da ribelle senza causa fuori tempo massimo, poi infilandomi come comparsa in film di registi più conosciuti come Woody o Pakula. Ma per quanti provini facessi e per quanti soggetti scrivessi, dello Stallone Italiano nessuno ne voleva sapere nulla. E avevo una moglie da mantenere di cui mi ero anche impegnato di nascosto qualche gioiello. Mentre mi arrabattavo ai margini o quasi dello schermo (un amico che non c’è più, Paul Bartel, mi fece fare ben due film, ma dal secondo fui tagliato fuori, come accadde anche in Mandingo), una sera, nel 1975, mi capitò di assistere in tv a un match tra un underdog arrabbiato, Chuck Wepner, e Cassius Clay.
Un cognome può essere più forte di un nome. Nessuno, per esempio, mi ha mai chiamato Gardenzio, sapete. E Sylvester è lunghetto per gli standard americani. E poi ricorda il gatto del canarino Titti. Quindi mi è toccato Sly tutta la vita, che va anche bene. Ma il cognome, dicevo, quello di papà “barbiere di Sicilia” di Broccolino da film dei vostri Franchi e Ingrassia, quello stava per fregarmi. Lo “Stallone Italiano”. Alé. Io sto messo bene là sotto, sapete? Vi ricordate quando Ciak pubblicò la mia foto di come mamma mi fece? Ecco. Il mio esordio davanti alla macchina da presa. The Party at Kitty and Stud’s (in Italia lo trovate in dvd come Italian Stallion/Porno proibito – un’esagerazione, era solo una cosina soft, ma appunto). Avevo 24 anni ed ero povero in canna, che volete farci. Avevo pure lasciato il college, per andare a New York a fare l’attore. Ma soft o porno che fosse, sapevo già che non sarei mai voluto diventare un altro Johnny Wadd, anche se insomma, avessi voluto dargli del filo da torcere, me la sarei cavata piuttosto bene. Era il 1970. E subito dopo feci un altro film, ma le mie scene furono eliminate al montaggio. E ci provarono, comunque, a lanciarmi: prima vestito da ribelle senza causa fuori tempo massimo, poi infilandomi come comparsa in film di registi più conosciuti come Woody o Pakula. Ma per quanti provini facessi e per quanti soggetti scrivessi, dello Stallone Italiano nessuno ne voleva sapere nulla. E avevo una moglie da mantenere di cui mi ero anche impegnato di nascosto qualche gioiello. Mentre mi arrabattavo ai margini o quasi dello schermo (un amico che non c’è più, Paul Bartel, mi fece fare ben due film, ma dal secondo fui tagliato fuori, come accadde anche in Mandingo), una sera, nel 1975, mi capitò di assistere in tv a un match tra un underdog arrabbiato, Chuck Wepner, e Cassius Clay.

Uno spettacolo di boxe messo su da quel volpone di Don King: un perdente contro un colosso, un Davide che non si sarebbe potuto prendere gioco di Golia. Folgorato, presi dei quaderni, e iniziai a scrivere. E ventiquattro ore dopo avevo pronta la sceneggiatura di Rocky. Un personaggio forse (ma sì) autobiografico. L’eroe che avrei voluto essere. Una proiezione di me. Perché io, nell’American Dream, ci ho sempre creduto. Ma nessuno voleva quello script, esattamente come i miei precedenti. E questo però era qualcosa di così potente e privato che non solo volevo piazzare il copione, ma volevo anche interpretarlo. Testardo, eh? Ero così alla canna del gas che ho venduto il mio cane, per 50 dollari. Ed ero così determinato a essere io Rocky che quando uno studio me ne offrì mille volte tanti per avere solo la sceneggiatura li rifiutai. Intanto il copione girava, e le offerte, sorprendentemente, salivano. Arrivarono fino a 400.000 dollari, più o meno. Ma nessuno voleva che lo interpretassi io. E io continuavo a rifiutare. Finché non me ne proposero 25.000. Per lo script, e l’ingaggio come attore. Fosse andata male, almeno i Chartoff e Winkler non ci avrebbero rimesso quanto pensavano di dare a Robert Redford, o Ryan O’Neal, o Burt Reynolds (ve lo immaginate Rocky con Burt?). E li presi. Sì. E cercai di ricomprarmi il cane a 150 dollari dal tipo a cui lo avevo venduto a 50, ma il tizio per ridarmelo voleva un cameo nel film e 15.000 dollari. E glieli diedi. E il film si fece. Il resto lo sapete. 10 nomination, tra cui le mie come miglior attore e sceneggiatore (chi aveva ragione?) e tre premi “trasformati”(Oscar a film, regia e montaggio). Non i miei. È buffo, ma l’unico premio come miglior attore che ho vinto per Rocky me lo avete dato voi: era un David di Donatello, nel 1977. Dopo, sono stato tante cose: un sindacalista polacco “martire”, il fratello di un lottatore (ah! La mia prima regia. Quante me ne hanno dette. Eppure in quel film c’era un’altra volta tutto quello che io sono), un poliziotto antiterrorista, un portiere di calcio improvvisato nella Parigi occupata del 1943, un tassista trasformato in star del country da Dolly Parton (come ho fatto a pensare che potesse funzionare?), un poliziotto dal nome improbabile (Marion Cobretti, ma si può?), un papà campione di braccio di ferro, un carcerato seviziato, un altro poliziotto “incastrato”, un boss italoamericano (qui mi chiamavo Provolone: vabbè) impegnato a diventare onesto, un poliziotto (un altro!) con action-mamma rompicoglioni, una guida di montagna, un poliziotto (ancora?) ibernato e scongelato nel futuro, un esperto di esplosivi CIA, un giudice-poliziotto (ehm…) da fumetto fantascientifico,un killer, un cittadino-eroe intrappolato un tunnel, uno sceriffo (uhm…) sordo, un recuperatore di debiti, un pilota Indy, un agente federale alcolizzato, un bodyguard, un pokerista imbattibile, un giocattolaio pazzo, un sicario con onore, un artista dilettante intrippato col web…

Non ho dimenticato nulla, credo. Ah, sì, certo. Sono stato anche un reduce del Vietnam, quattro volte, le prime tre più o meno incomprese dai critici ma non da voi spettatori, e una quarta su cui tornerò tra poco. [Ho fatto anche il regista in un film in cui non ho recitato: ma ancora una volta ho trasferito me stesso in un corpo, facendo diventare il Tony Manero di John Travolta una specie di Rocky di Broadway. Vi ricordate Staying Alive?) Però innanzitutto, sono stato Rocky. Il mio amico immaginario numero uno (l’altro è John Rambo). Lui mi accompagna da sempre. Abbiamo sfidato e vinto Apollo alla fine degli anni Settanta, abbiamo attraversato con strafottenza da supereroi (i tempi lo richiedevano, ma mica facevamo sul serio) gli anni Ottanta, abbiamo inaugurato i Novanta tornando poveri in mezzo alla strada e ci siamo poi confrontati con gli anni Duemila, il digitale, l’essere fantasmi, lo scomparire dalla contemporaneità per entrare nel Mito. Credevo che quella volta, nel 2006, sarebbe stata l’ultima. E credevo che fosse arrivato il momento anche di salutare John. Così, due anni dopo, gli ho costruito attorno un film quasi gemello dell’ultimo con Rocky (non a caso intitolato come quello con nome e cognome del mio amico). Perché è stato in quegli anni che ho capito che il mio ruolo era stato definitivamente scritto; che, come dicono i critici, l’icona aveva avuto la meglio sul Sylvester Gardenzio detto Sly Stallone Italiano che ancora  voleva fare film. E infatti mi sono concesso degli scherzi, delle strizzate d’occhio, dei giochi (“metafilmici”, li chiama ancora qualcuno): tipo i tre episodi con gli Expendables, le carcasse sacrificabili dell’epopea dell’action movie che ho modestamente contribuito a edificare, girando dentro e fuori e attorno e sopra all’idea di essere un eroe, sì, ma sempre intimamente proletario, a volte anche un po’ opportunista e a volte anche un po’ fascista, come a volte possono essere senza crederci troppo i proletari veri. O tipo l’accoppiata fuori tempo massimo col mio vecchio amico Schwarzy. O tipo quell’altro pugile da barzelletta che le ha suonate a De Niro (De Niro. Pugile. Che risate mi sono fatto). Perché ho pensato che tanto, dopo quella bella Notte degli Oscar del 1977 e quella miriade di vite che vi ho raccontato prima, di nomination non me ne sarebbe più arrivata una neanche per sbaglio. E che forse mi sarei dovuto accontentare di uno di quegli Oscar alla carriera che di solito sono l’anticamera della morte vera dopo che uno magari la pelle l’ha rischiata per finta innumerevoli volte. E invece. Eccomi qua. Che vi scrivo mentre sto per andare al Dolby Theatre, ancora una volta nominato per aver interpretato Rocky in un film che per ironia della sorte ha il titolo del suo primo e indimenticato antagonista. Non so se negli anni sono davvero migliorato come attore. Di certo ho fatto dei film in cui ero cane (però in Cop Land ero bravissimo, e non mi si è filato un cane), e ne ho sbagliati parecchi. Ma non avrei fatto Creed se non avessi sentito dentro di me ancora una volta la possibilità e la voglia di dimostrare che malgrado tutto, a settant’anni quasi suonati, un pezzo di Sogno Americano sono ancora io, e che anche il mito della seconda possibilità (o terza, quarta, quinta: quante volte sono rinato in questi quarant’anni…) è ancora vivo e io sono lì, la dimostrazione vivente. Ho già vinto tredici premi, grandi e piccoli (merito anche di Ryan che per la prima volta ha capito davvero come tenermi a bada e come sottrarre significhi in realtà aggiungere), per questo Rocky ancora più dimesso e laterale e finale (ma chi può dirlo?) dell’ultima volta, per questo colosso che ha sofferto tanto ma che forse ha anche dato a chi soffriva la forza di guardare avanti e rialzarsi. Ora, non mi vergogno a dirlo, vorrei quell’Oscar che non ho mai avuto. Non solo per Rocky. Anche per John (sì). E per me. Per uomini che hanno attraversato tante americhe, osservato tante trasformazioni, sognato tanti sogni infranti, che sono sopravvissuti alla morte dei propri figli (eh…) e hanno vissuto e fatto vivere tante vite che in realtà sono sempre state una sola. Me lo merito. Ce lo meritiamo. Io, Rocky, John. E un po’ anche voi.
voleva fare film. E infatti mi sono concesso degli scherzi, delle strizzate d’occhio, dei giochi (“metafilmici”, li chiama ancora qualcuno): tipo i tre episodi con gli Expendables, le carcasse sacrificabili dell’epopea dell’action movie che ho modestamente contribuito a edificare, girando dentro e fuori e attorno e sopra all’idea di essere un eroe, sì, ma sempre intimamente proletario, a volte anche un po’ opportunista e a volte anche un po’ fascista, come a volte possono essere senza crederci troppo i proletari veri. O tipo l’accoppiata fuori tempo massimo col mio vecchio amico Schwarzy. O tipo quell’altro pugile da barzelletta che le ha suonate a De Niro (De Niro. Pugile. Che risate mi sono fatto). Perché ho pensato che tanto, dopo quella bella Notte degli Oscar del 1977 e quella miriade di vite che vi ho raccontato prima, di nomination non me ne sarebbe più arrivata una neanche per sbaglio. E che forse mi sarei dovuto accontentare di uno di quegli Oscar alla carriera che di solito sono l’anticamera della morte vera dopo che uno magari la pelle l’ha rischiata per finta innumerevoli volte. E invece. Eccomi qua. Che vi scrivo mentre sto per andare al Dolby Theatre, ancora una volta nominato per aver interpretato Rocky in un film che per ironia della sorte ha il titolo del suo primo e indimenticato antagonista. Non so se negli anni sono davvero migliorato come attore. Di certo ho fatto dei film in cui ero cane (però in Cop Land ero bravissimo, e non mi si è filato un cane), e ne ho sbagliati parecchi. Ma non avrei fatto Creed se non avessi sentito dentro di me ancora una volta la possibilità e la voglia di dimostrare che malgrado tutto, a settant’anni quasi suonati, un pezzo di Sogno Americano sono ancora io, e che anche il mito della seconda possibilità (o terza, quarta, quinta: quante volte sono rinato in questi quarant’anni…) è ancora vivo e io sono lì, la dimostrazione vivente. Ho già vinto tredici premi, grandi e piccoli (merito anche di Ryan che per la prima volta ha capito davvero come tenermi a bada e come sottrarre significhi in realtà aggiungere), per questo Rocky ancora più dimesso e laterale e finale (ma chi può dirlo?) dell’ultima volta, per questo colosso che ha sofferto tanto ma che forse ha anche dato a chi soffriva la forza di guardare avanti e rialzarsi. Ora, non mi vergogno a dirlo, vorrei quell’Oscar che non ho mai avuto. Non solo per Rocky. Anche per John (sì). E per me. Per uomini che hanno attraversato tante americhe, osservato tante trasformazioni, sognato tanti sogni infranti, che sono sopravvissuti alla morte dei propri figli (eh…) e hanno vissuto e fatto vivere tante vite che in realtà sono sempre state una sola. Me lo merito. Ce lo meritiamo. Io, Rocky, John. E un po’ anche voi.

Grazie
Il vostro Sylvester Sly Gardenzio Stallone Italiano.


