 Qualcosa bolle in pentola. Qualcosa di oscuro, inquietante, dolorosamente attuale. Chiarelettere, un editore che solitamente si occupa tutt’altro, nell’ambito di quello che sembra un rinnovato interesse per la letteratura di genere ha deciso di pubblicare, a cura di Michele Vaccari, una collana, Altrove, che si occupa di speculative fiction, un genere capace, in quella sua declinazione che va da George Owell a Black Mirror, di leggere la realtà quotidiana in maniera tanto lucida quanto poco confortante. La festa nera, di Violetta Bellocchio, già collaboratrice del Duel cartaceo, ci racconta questo suo libro attuale quanto inquietante.
Qualcosa bolle in pentola. Qualcosa di oscuro, inquietante, dolorosamente attuale. Chiarelettere, un editore che solitamente si occupa tutt’altro, nell’ambito di quello che sembra un rinnovato interesse per la letteratura di genere ha deciso di pubblicare, a cura di Michele Vaccari, una collana, Altrove, che si occupa di speculative fiction, un genere capace, in quella sua declinazione che va da George Owell a Black Mirror, di leggere la realtà quotidiana in maniera tanto lucida quanto poco confortante. La festa nera, di Violetta Bellocchio, già collaboratrice del Duel cartaceo, ci racconta questo suo libro attuale quanto inquietante.
Presentati in breve. Chi è Violetta Bellocchio e qual è il suo percorso di autrice?
Violetta Bellocchio è una ragazzina disadattata che a quindici anni si ritrova al cinema a vedere Candyman – Terrore dietro lo specchio senza capirci troppo: voleva solo stare fuori casa. Comincia a scrivere molto giovane quando sa fare molto poco, ma col tempo impara il mestiere e un po’ prende la mano. Gira mille giornali diversi e li lascia quando sente di aver imparato tutto il possibile. A un certo punto infila una nonfiction che diventa famigerata per il suo contenuto più che per lo stile. Scrive come Joan Didion e ha l’immaginario di Ruggero Deodato, quindi quasi nessuno capisce mai da quale verso prenderla, però, al netto, è l’unica autrice italiana ad avere un involontario dialogo a distanza con Bret Easton Ellis. Siamo messi così, stateci.
Nel tuo ultimo libro, La festa nera, è presente una visione della fine della civiltà per così dire morbida, un processo niente affatto clamoroso né immediato, una distopia quasi  soft rispetto ad altri scenari più marcati e teatrali dipinti da opere del genere. Ce ne vuoi parlare? Quale mondo dopo la fine del mondo, nelle tue parole?
soft rispetto ad altri scenari più marcati e teatrali dipinti da opere del genere. Ce ne vuoi parlare? Quale mondo dopo la fine del mondo, nelle tue parole?
Quando ho cominciato il lavoro sul romanzo (breve, tra l’altro) sapevo che tratteggiare uno scenario apocalittico in piena regola era un’impresa superiore alle mie forze, e che non era quello il punto focale del mio interesse verso il genere. Ma avevo letto Ballard, conoscevo a fondo il lavoro di Charlie Brooker e dei suoi co-autori, che raccontano sempre un futuro prossimo quasi identico al presente fatta salva una piccola differenza (di solito un’innovazione tecnologica applicata molto male). E poco prima di attaccare la prima vera stesura avevo letto, per dovere e curiosità, The Mandibles di Lionel Shriver, che descrive una società occidentale al collasso per ragioni economiche, non ambientali o socio-politiche. Alla fine sapevo che stavo scrivendo una storia – un what if, se vuoi – che cercava di raccontare un’apocalisse alla portata di molti: un graduale processo di erosione della fiducia nella possibilità di convivere civilmente con il resto del mondo, e quindi, fatalmente, un aumento del fascino della vita appartata, laterale, periferica per  collocazione e vocazione, quando non la chiusura rigida in una filter bubble dove non può arrivare nulla che ti costringa a prendere in considerazione altre maniere di concepire la realtà. In effetti mi sembra che questa “distopia soft” corrisponda già alla routine quotidiana di parecchi nel 2018. O forse lo penso soltanto perché mi è capitato sia di vivere in un pezzo di provincia italiana abbastanza bravo a fare quadrato intorno a poche idee, sia di abitare in una grande città in cui è impossibile incontrare persone diverse da te a meno che non ti vadano a sbattere addosso per la strada o non ti fermano per chiederti se hai dei soldi.
collocazione e vocazione, quando non la chiusura rigida in una filter bubble dove non può arrivare nulla che ti costringa a prendere in considerazione altre maniere di concepire la realtà. In effetti mi sembra che questa “distopia soft” corrisponda già alla routine quotidiana di parecchi nel 2018. O forse lo penso soltanto perché mi è capitato sia di vivere in un pezzo di provincia italiana abbastanza bravo a fare quadrato intorno a poche idee, sia di abitare in una grande città in cui è impossibile incontrare persone diverse da te a meno che non ti vadano a sbattere addosso per la strada o non ti fermano per chiederti se hai dei soldi.
La festa nera è molte cose, tra cui un viaggio che per certi versi mi ricorda Cuore di tenebra di Joseph Conrad, con un succedersi di tappe rappresentate da comuni autarchiche lungo una valle isolata. Qual è il senso di queste tappe? Che cosa rappresentano?
Il primo senso, in brevissimo, si lega alla necessità di mantenere la storia in movimento: non avevo mai scritto un testo lungo che dovesse tenere vivo il lettore e allo stesso tempo spingersi, anche aggressivamente, verso una linea fissata come “il finale”, quindi per me è stato immediato, da subito, che questi personaggi e queste parti del mondo non le si potevano raccontare a partire da uno stato di quiete. Quindi la tensione funziona su più livelli: c’è quella esterna del viaggio, c’è quella, interna, dello scoprimento graduale del passato dei personaggi e dei diversi legami che li uniscono, e poi c’è sempre la botta materiale legata all’atto del bussare alla porta di una comunità chiusa, sperando di poter vedere tutto quanto quella bolla offre allo sguardo di un estraneo. In concreto, sapevo come sarebbe finito il libro, ma non sapevo come si sarebbe delineato tappa per tappa fino al giorno in cui ho aperto il file. Tra l’altro mi sono calata nei personaggi con un livello di identificazione che per me è sempre l’unica maniera di lavorare: avevo in mano un itinerario di massima, ma delle singole tappe ho scelto di sapere pochissimo prima di iniziare il lavoro sulle singole sezioni del romanzo. Dovrei ancora avere da parte gli appunti smozzicati che prendevo su un quaderno: i nomi dei posti, tre/quattro indicazioni di massima (“qui dentro succede questo”), alcuni dettagli concreti che si sarebbero subito presentati all’occhio dei personaggi (“ragazzina in skate con gonna fermata in vita da piuma di pavone”, “ragazzo solleva pantaloni, mostra protesi al titanio”, e così via). Rinascita creativa? Sì. Ma se provo la stessa tecnica due volte non mi riesce più. Per rispetto di chi è venuto prima di me, sarà bene dire che la fonte di ispirazione non dichiarata non è stata tanto Cuore di tenebra quanto Lost Soul: The Doomed Journey of Richard Stanley’s Island of Dr. Moreau, un documentario del 2014 che ricostruisce, con una precisione raggelante, tutto quanto è andato storto nel tentativo da parte di Stanley di girare L’isola perduta. Film che infatti è stato terminato da Frankenheimer e ha portato alla follia praticamente chiunque ci abbia posato sopra le zampe. Lo consiglio a chiunque cerchi di misurarsi con la creatività, in piccolo o su vasta scala, è come una lista di cosa non fare.
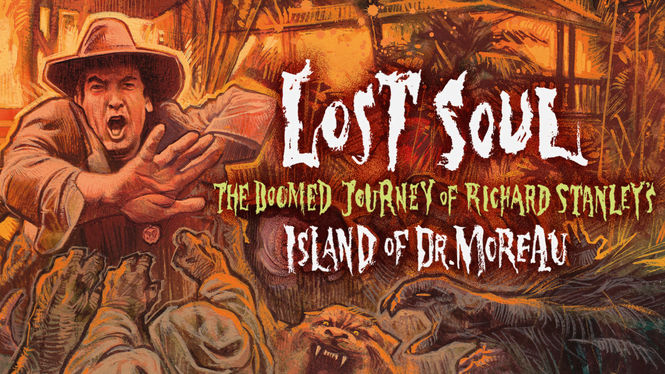
Forte è, nel tuo romanzo, la riflessione sulla contemporaneità, nella fattispecie rapporto fra i media moderni, la verità e il comportamento di quella che, per semplificare, potremmo definire l’opinione pubblica. Ti andrebbe di approfondire?
C’è un passaggio in cui uno dei personaggi, Nicola, cerca di raccontare alla narratrice le motivazioni del suo essersi preso come compagna di vita e di lavoro una donna che forse è sempre stata instabile, di certo non gli ha regalato mai nulla. Lui la mette così: “la morale, figlia mia, è un incubo. Sai dove cominci e non sai dove finisci. Tiri una riga oggi, tiri una riga domani, rischi di non prendere mai posizione su niente”. Nicola si esprime in questo modo sapendo benissimo di aver poi tagliato con l’accetta moltissimo materiale su cui ha lavorato nel corso degli anni, e di essere stato abbastanza bravo, o fortunato, da diventare un piccolo re del gonzo journalism del futuro, quello dove l’abilità di chi produce un reportage sta sempre nel suo fiuto per “la storia forte”, nell’assenza di scrupoli quando si tratta di convincere a parlare anche persone fragili che andrebbero protette. Ci capita di vivere in un tempo presente che nessuno di noi avrebbe immaginato con tanta nettezza: a vincere, per ora, sembrano essere stati la manipolazione sistematica del reale in nome di un’agenda politica confusa, caotica, destinata ad essere ricostruita ogni giorno, e un senso della propria opinione come l’unico punto di vista valido da cui osservare la società. Del resto, una certa deriva umana, le persone come me purtroppo l’avevano vista arrivare da anni, vuoi perché non hanno mai avuto una vita corrispondente ad alcuno standard aureo di “rispettabilità” e “inattaccabilità”, vuoi perché hanno occupato vari slot del bingo della diversità. Non è mai stato facile prendersi o trovarsi uno spazio come artista femmina, per dire. La verità interessa ancora a molti. Peccato che troppi artisti/commentatori non si siano misurati abbastanza con la complessità della narrazione, che sia un piccolo reportage magari maldestro o un progetto di storytelling politico che finisce per influenzarci tutti in quanto cittadini. Fuor di metafora: avere a che fare con la realizzazione di contenuti – testi scritti, filmati o disegnati – implica comunque l’accettare di esprimere un punto di vista con l’atto stesso del decidere quali parole utilizzi, dove posizioni la telecamera (o il telefono), cosa piazzi in centro campo e cosa lasci o sistemi ai margini, eccetera. Ed è ovvio che non esistono narrazioni sia forti sia obiettive al 100%. Ci siamo sfasciati la testa cercando di produrre “contenuti inattaccabili”, intanto la pancia dell’Italia chiedeva ben altro, e… appunto, quello che dice Nicola sulla morale. È un incubo, non se ne esce.
Il tuo libro e il progetto entro il quale è inserito, la collana Altrove, iniziativa eccezionale per un editore come Chiarelettere che, occupatosi da sempre di tutt’altro, decide di pubblicare narrativa di genere. Che senso ha tutto questo nel panorama letterario italiano? Cosa bolle in pentola?
Non lo so. Sono stata abbastanza fortunata da avere la possibilità di scrivere speculative fiction a partire dal mio lavoro con la nonfiction personale (Il corpo ma anche alcuni longform che a suo tempo mi avevano creato non pochi problemi), quindi mi sento, a modo mio, un’autrice privilegiata che può muoversi su più tavoli, non un’anticipatrice di nulla: la narrativa di genere l’abbiamo sempre fatta, è il caso di ricordarcelo, tanto quanto Mario Bava, Fulci e Deodato erano roba nostra prima di diventare autori con un enorme seguito mondiale. (Tengo a precisare che il curatore Michele Vaccari prima di farmi una proposta di lavoro mi aveva letto con cura ma incrociata socialmente forse una o due volte: bravo lui che ha intravisto qualcosa nel mio materiale, dunque, e che ha capito quanto mi sentissi affaticata dalla richiesta di “fare la donna” in modi creativamente futili se non controproducenti.) Chiarelettere è un editore solido e, come dici tu, specializzato in reportage, libri d’inchiesta su più fronti. Potrebbe aver avuto il coraggio e anche la furbizia di varare un progetto “di genere” ma anche popolare, in un momento in cui mi pare che una buona fetta della classe creativa italiana si sia specializzata nel muoversi il meno possibile: la paura di sbagliare è tanta che per non rischiare si finisce per non fare nulla. (Al massimo ci si lamenta del tempo che passa, giuro.) E questo, va da sé, non soltanto non colloca in libreria romanzi o nonfiction migliori, ma può devastare e prosciugare chiunque voglia portare avanti un percorso, chiunque voglia sperimentare con forma e/o contenuto. Ho visto veri autori bruciarsi per correre dietro alle reali o immaginarie “richieste del mercato” come ho visto professionisti brillanti arrivare a un punto di esasperazione personale nei confronti della generale piattezza dell’offerta, tanto che parecchi compagni di strada, oggi, si sono buttati a fare tutt’altro.
Quali sono le potenzialità e la funzione della letteratura, in particolar modo del fantastico, in un mondo dove essa si trova a competere con nuovi media dalle possibilità enormi e, soprattutto, in un paese come il nostro dove la lettura sembra perennemente tendente al calo? Che senso ha scrivere oggi?
La dico dritta: siamo in un momento di estremo impoverimento che non è per forza destinato a innescare una nuova rinascita espressiva, però potrebbe, se gliene diamo la chance. La letteratura fantastica è da sempre uno spazio amico per chiunque voglia provare a fare politica o a dire qualcosa senza alienarsi un pubblico che comunque un po’ di storia e un po’ di personaggi li vuole seguire e difficilmente prenderebbe in mano una nonfiction, che ne so, sulla violenza del potere o sulla diversità come arma a doppio taglio. Se mi sposto un attimo dallo specifico editoriale, penso al lavoro gigantesco che facevano i padri del new horror negli anni ’70 (anche se alcuni, come Craven, forse hanno ammantato le loro opere di “evidenti 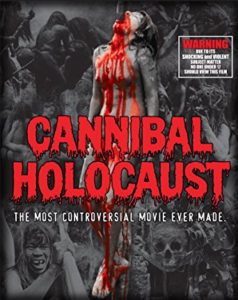 intenti politici” quando si sono ritrovati chiusi in un angolo e tacciati di immoralità), e a quello che oggi sta facendo il fumetto per andare ad abbracciare e ricaricare un pubblico molto giovane, disperso in un mondo che non gli parla e non lo rappresenta. In estrema sintesi, chi sa scrivere, scriva. Chi sa disegnare, disegni. Chi sa girare, giri. Chi ha i soldi, produca. Abbiamo bisogno di tutti.
intenti politici” quando si sono ritrovati chiusi in un angolo e tacciati di immoralità), e a quello che oggi sta facendo il fumetto per andare ad abbracciare e ricaricare un pubblico molto giovane, disperso in un mondo che non gli parla e non lo rappresenta. In estrema sintesi, chi sa scrivere, scriva. Chi sa disegnare, disegni. Chi sa girare, giri. Chi ha i soldi, produca. Abbiamo bisogno di tutti.


