 Poiché tutti i salmi finiscono in gloria, la squadra italiana di volley allenata da Julio Velasco, che immagino verrà invocato “santo subito”, ha annichilito gli Stati Uniti, conquistando il dodicesimo oro della spedizione azzurra e la quarantesima medaglia in totale, così da migliorare il fatturato di Tokyo. Immagino pertanto che il presidente del Coni Malagò si sia presentato trionfante alla conferenza stampa conclusiva a casa Italia, che ho disertato al pari della cerimonia di chiusura. Al di là delle dichiarazioni della politica, sportiva e non (vorrei sapere a chi interessano i commenti di Meloni, Schlein, Conte, Vannacci e compagnia cantante) questa edizione dei Giochi va in archivio con un bilancio positivo per l’Italia. Che ha patito alcune assenze pesanti (Sinner in primis e di fatto anche Tamberi), ha visto sfumare una manciata di medaglie che sembravano alla portata – la 4×100 ad esempio, ma pure la scherma ha lasciato per strada qualcosa e non solo per gli arbitri brutti sporchi e cattivi (Ettore Scola, 1976, con uno strepitoso Nino Manfredi) – ma ne ha trovate altre impronosticabili alla vigilia, quali l’oro alla trave della pur brava Alice D’Amato o quello nella Madison femminile di Consonni-Guazzini. È l’Olimpiade bellezza! E tu non puoi farci niente! Niente (libero adattamento della battuta finale de L’ultima minaccia, Richard Brooks, 1952). Dunque 12 ori, 13 argenti e 15 bronzi, unico metallo in flessione rispetto a tre anni fa, conseguenza della notevole messe di quarti posti, ben venti, che inviterei a non liquidare come medaglie di cartone: meritano forse il disprezzo insito in quell’immagine i piazzamenti di Nadia Battocletti nei 5.000 o di Stefano Sottile nell’alto? E potrei facilmente continuare con gli esempi. (In apertura la Paris Défense Arena. Le immagini sono di Franco Bassini).
Poiché tutti i salmi finiscono in gloria, la squadra italiana di volley allenata da Julio Velasco, che immagino verrà invocato “santo subito”, ha annichilito gli Stati Uniti, conquistando il dodicesimo oro della spedizione azzurra e la quarantesima medaglia in totale, così da migliorare il fatturato di Tokyo. Immagino pertanto che il presidente del Coni Malagò si sia presentato trionfante alla conferenza stampa conclusiva a casa Italia, che ho disertato al pari della cerimonia di chiusura. Al di là delle dichiarazioni della politica, sportiva e non (vorrei sapere a chi interessano i commenti di Meloni, Schlein, Conte, Vannacci e compagnia cantante) questa edizione dei Giochi va in archivio con un bilancio positivo per l’Italia. Che ha patito alcune assenze pesanti (Sinner in primis e di fatto anche Tamberi), ha visto sfumare una manciata di medaglie che sembravano alla portata – la 4×100 ad esempio, ma pure la scherma ha lasciato per strada qualcosa e non solo per gli arbitri brutti sporchi e cattivi (Ettore Scola, 1976, con uno strepitoso Nino Manfredi) – ma ne ha trovate altre impronosticabili alla vigilia, quali l’oro alla trave della pur brava Alice D’Amato o quello nella Madison femminile di Consonni-Guazzini. È l’Olimpiade bellezza! E tu non puoi farci niente! Niente (libero adattamento della battuta finale de L’ultima minaccia, Richard Brooks, 1952). Dunque 12 ori, 13 argenti e 15 bronzi, unico metallo in flessione rispetto a tre anni fa, conseguenza della notevole messe di quarti posti, ben venti, che inviterei a non liquidare come medaglie di cartone: meritano forse il disprezzo insito in quell’immagine i piazzamenti di Nadia Battocletti nei 5.000 o di Stefano Sottile nell’alto? E potrei facilmente continuare con gli esempi. (In apertura la Paris Défense Arena. Le immagini sono di Franco Bassini).

Prima di proseguire invece nei bilanci e nelle considerazioni finali, ecco il diario di giornata, come è abitudine ed è anche nello spirito di Midnight in Paris. Sabato sera, dopo aver dato appuntamento ai lettori all’Arena Paris Sud per la finale del volley femminile, in programma alle 13 di domenica, ho scoperto che un’ora più tardi si sarebbe disputata a La Défense Arena la finale di pallanuoto tra Serbia e Croazia. Dico tra Serbia e Croazia, ovvero due tifoserie (e non solo) separate da una fiera rivalità; non Italia e Ungheria, giusto per citare altre due nazioni che hanno scritto la storia olimpica di questa disciplina, che non si sparano addosso dal 15-18 e ultimamente si trovano pure in particolare sintonia, almeno a livello di premier. Rifletto: tutti gli italiani avranno visto in televisione il volley e a qualcuno potrebbe magari interessare lo stato di salute del tanto citato spirito olimpico. Opto quindi per la pallanuoto e ora posso affermare che sta bene, meglio di quanto pensassi. Prima di entrare nei particolari, consentitemi di spendere due parole su questo impianto che nella prima settimana aveva ospitato le gare di nuoto e del quale i colleghi mi avevano detto meraviglie. Inaugurato nel 2017, inserito in un contesto modernissimo, anzi futuribile, non solo ha una capienza di oltre 15.000 posti per gli incontri di rugby del Racing 92, così come in questi giorni in cui è stato dotato di una piscina olimpionica (un po’ bassina, per alcuni, ma d’altronde vasca in francese si dice bassin), ma può arrivare a 40.000 quando ospita concerti (il 4 e 5 dicembre tornerà sir Paul McCartney, che già si era esibito nel novembre 2018: non penso sia necessario aggiungere altri nomi, se non quello dei Rolling Stones per antica par condicio). Struttura polivalente come poche altre, dotata anche dello schermo interattivo più grande al mondo, è stata utilizzata anche per adunate (termine che sta tornando in voga nella nostra nazione) politiche.

Insomma, uno spettacolo, esattamente come la viabilità sotterranea per raggiungerla (si trova all’estrema periferia ovest di Parigi, tecnicamente nel comune di Nanterre). All’andata ho preso la metro 1, al ritorno la Rer E: treni e stazioni pulite, scale mobili che funzionano… Sì, stavo pensando a Roma e alla candidatura ordita a fine 2014 da Renzi e Malagò (chi si assomiglia si piglia), ufficializzata l’11 settembre 2015 dopo che Luca di Montezemolo era stato individuato come presidente dell’eventuale comitato organizzatore (vedi parentesi precedente) e ritirata il 21 settembre 2016 dalla neosindaca Virginia Raggi, che se non altro aveva iniziato bene. Ma torniamo al test sullo spirito olimpico (l’avevo già accennato a Tokyo: sono il nuovo dottor Divago). Superato a pieni voti sia dai tifosi – non un fischio durante l’esecuzione degli inni nell’imminenza della partita – sia dai giocatori, che si sono scambiati strette di mano e pure qualche abbraccio prima e dopo il match, che la Serbia ha vinto 13-11, conquistando così il terzo oro consecutivo, ovvero il settimo podio di fila, se consideriamo i bronzi del 2012, del 2008 e del 2000, quando la denominazione era Jugoslavia, e l’argento del 2004, come Serbia e Montenegro. E all’uscita le due tifoserie si sono mescolate senza alcun momento di tensione. Niente a che vedere con quanto avviene nei nostri stadi di calcio, dove i supporter della squadra in trasferta vengono trattenuti negli spicchi di curva a loro riservati finché l’impianto non si è svuotato e poi sono scortati dalle forze dell’ordine fino ai mezzi che li portano in stazione.

Ed eccoci ai numeri. Grazie alla vittoria di un sol punto sulla Francia nella finale di basket femminile che ha chiuso le competizioni, gli Stati Uniti primeggiano nel medagliere, avendo gli stessi 40 ori della Cina, ma un’infinità di argenti e bronzi in più. Le prime dieci nazioni classificate sono le stesse di Tokyo e Rio, ovviamente non nello stesso ordine, se non consideriamo la Russia, quarta in Brasile, ma già assente in Giappone, allora per motivi disciplinari, ovvero il comprovato ricorso al doping. L’Europa, al solito, è il continente che ha vinto più medaglie d’oro, 123, mentre i 27 Stati membri della Ue, con 102, da soli pareggiano quelle dell’Asia, cui pure abbiamo generosamente attribuito le tre della Georgia e quella di Israele, le cui squadre di club partecipano però alle competizioni europee… Infine le Americhe, sommando Nord, Centro e Sud, si fermano a 62, l’Oceania a 28 e l’Africa a 13. Considerazioni transitorie e finali. I 99 scalini favoriscono la concentrazione, ma non l’igiene. Dopo la prima volta che mi sono dimenticato l’accredito e sono dovuto rientrare, ho sempre fatto mente locale prima di chiudere la porta e non ho più scordato nulla. La prospettiva di salire per poi ridiscendere per mangiare fuori mi consigliava invece di andare direttamente al bar o al ristorante e utilizzare quindi un bagno meno pulito di quello di casa. Perdere la metro per pochi secondi non è mai stato un problema: la successiva, anche a sera avanzata, non tardava più di tre minuti. Tutti i poliziotti che mi hanno perquisito non so quante volte in queste tre settimane sono stati educati e rispettosi. Vi dovevo poi qualche notizia sulle protagoniste della gara di ginnastica a squadre ai Giochi di Amsterdam 1928, nella quale l’Italia, rappresentata da dodici adolescenti pavesi, conquistò una medaglia d’argento rimasta l’unica per 96 anni. Luigina Giavotti, con i suoi undici anni e trecento giorni, è tuttora (e presumibilmente rimarrà sempre) la più giovane atleta ad aver partecipato alle Olimpiadi. La ginnasta più forte del gruppo, Carla Marangoni, classe 1915, vivrà oltre 102 anni, spegnendosi nel gennaio del 2018, sempre a Pavia, mentre Bianca Ambrosetti, nata il primo marzo del ‘14, in gara nonostante fosse tisica, verrà a mancare già il 30 novembre del ‘28. Cinque delle 12 ragazze olandesi che vinsero l’oro erano ebree: furono tutte deportate, in alcuni casi insieme ai figli ancora bambini, e uccise nel 1943 nel campo di sterminio di Sobibor.

Il vistoso accredito plastificato che portiamo al collo ha attirato spesso l’attenzione sui mezzi pubblici: alcuni cercavano di leggere il nome o più probabilmente il Paese di provenienza, altri si limitavano a sorriderti, ma non mancavano quelli più curiosi e/o ciarlieri: d’où est-ce que tu viens? Domenica mattina, complice la giornata calda e il fatto che uscivo tardi per tornare presto, ho indossato la canottiera da basket con la scritta Italia e il relativo scudetto (senza trascurare di mettere nello zaino la fida felpona: e se la Défense Arena fosse un’altra Bercy? No, per fortuna). Così ai primi due che mi hanno chiesto da dove venissi, ho risposto con un sorriso, mentre univo sul petto gli indici e i pollici delle due mani per poi allontanarli strisciando sulla canottiera, come a inquadrare la scritta, nel classico gesto degli atleti quando vengono presentati. Con il terzo avevo già esaurito la pazienza – non proprio la specialità 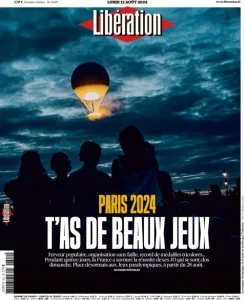 della casa – e mi è scappato un secco: endùina, che nel mio paese natale significa indovina. Un attimo di perplessità e poi un cenno d’assenso. Idem con il successivo, probabilmente un olandese, dato che era vestito d’arancione e con tutti gli altri (da Chatelet a La Défense sono una almeno una dozzina di fermate). Endùina si è rivelata una risposta azzeccata, anzi convincente. E mi piace pensare che mentre io sto scrivendo, qualcuno stia consultando Internet alla ricerca di un Paese mai sentito prima. Magari, chissà, dalle parti dell’Indocina.
della casa – e mi è scappato un secco: endùina, che nel mio paese natale significa indovina. Un attimo di perplessità e poi un cenno d’assenso. Idem con il successivo, probabilmente un olandese, dato che era vestito d’arancione e con tutti gli altri (da Chatelet a La Défense sono una almeno una dozzina di fermate). Endùina si è rivelata una risposta azzeccata, anzi convincente. E mi piace pensare che mentre io sto scrivendo, qualcuno stia consultando Internet alla ricerca di un Paese mai sentito prima. Magari, chissà, dalle parti dell’Indocina.


