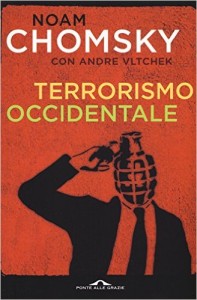 In Terrorismo occidentale (Ponte alle Grazie, pag.232, euro 16) Noam Chomsky dialoga con Andre Vltchek e prende in esame i peggiori crimini compiuti dall’Occidente dal secondo dopoguerra ad oggi. Con passione e lucidità il saggio evidenzia che l’Occidente proclama guerra al terrorismo ma è il più grande artefice del terrore:”dal secondo dopoguerra per colpa del colonialismo e del neocolonialismo sono scomparse fra i 50 e i 55 milioni di persone. In un arco di tempo relativamente breve, si è registrato il maggior numero di stragi della storia; molte di esse sono state perpetrate in nome di nobili ideali come la libertà e la democrazia.” Affrontando diverse questioni Chomsky e Vltchek si muovono nelle diverse aree geopolitiche, dall’Europa orientale al Sudest asiatico, dall’Africa al Medio Oriente al Sudamerica svelando gli interessi dell’imperialismo che si nasconde dietro a guerre, massacri e miseria. Qui sotto pubblichiamo uno stralcio dal saggio nel quale Chomsky analizza il rapporto fra gli americani e il massacro dei nativi, lo schiavismo e infine il lento risveglio delle coscienze ai tempi della guerra in Vietnam.
In Terrorismo occidentale (Ponte alle Grazie, pag.232, euro 16) Noam Chomsky dialoga con Andre Vltchek e prende in esame i peggiori crimini compiuti dall’Occidente dal secondo dopoguerra ad oggi. Con passione e lucidità il saggio evidenzia che l’Occidente proclama guerra al terrorismo ma è il più grande artefice del terrore:”dal secondo dopoguerra per colpa del colonialismo e del neocolonialismo sono scomparse fra i 50 e i 55 milioni di persone. In un arco di tempo relativamente breve, si è registrato il maggior numero di stragi della storia; molte di esse sono state perpetrate in nome di nobili ideali come la libertà e la democrazia.” Affrontando diverse questioni Chomsky e Vltchek si muovono nelle diverse aree geopolitiche, dall’Europa orientale al Sudest asiatico, dall’Africa al Medio Oriente al Sudamerica svelando gli interessi dell’imperialismo che si nasconde dietro a guerre, massacri e miseria. Qui sotto pubblichiamo uno stralcio dal saggio nel quale Chomsky analizza il rapporto fra gli americani e il massacro dei nativi, lo schiavismo e infine il lento risveglio delle coscienze ai tempi della guerra in Vietnam.
Già negli anni Sessanta cominciò un processo di incivilimento della società americana. E oggi c’è un margine di azione ancora maggiore all’interno della cultura ufficiale; una libertà che sarebbe stata impensabile negli anni Cinquanta e Sessanta, che furono una fase di profondo conformismo. Di recente mi sono recato a Greensboro, nel North Carolina, per un ciclo di conferenze su Israele e Palestina. Cinque o dieci anni fa non mi sarebbe stato possibile affrontare questi temi; avrei avuto bisogno della scorta persino al MIT. Oggi invece l’uditorio è foltissimo, c’è grande interesse e ci si interroga sulla validità delle politiche statunitensi. Rispetto al passato, le persone sono più disponibili a valutare le ripercussioni delle azioni americane.
Non voglio dire che sia un cruccio costante della società, ma sicuramente attira molto di più l’attenzione. Prendiamo per esempio i due crimini più efferati nella storia degli Stati Uniti, ossia lo sterminio pressoché totale della popolazione indigena (per usare le parole dei Padri fondatori) e lo schiavismo.
Fino agli anni Sessanta persino gli antropologi più esperti sostenevano che all’epoca della scoperta dell’America erano presenti sul territorio pochi indiani americani e che si trattava perlopiù di cacciatori-raccoglitori. Solo nel 1974, se non sbaglio, fu pubblicato il primo studio serio che sconfessava quella leggenda: L’invasione dell’America, di Francis Jennings. Altri volumi erano stati scritti in precedenza, ma erano stati subito messi al bando. Nel 1881 Helen Hunt Jackson, ad esempio, aveva pubblicato una ricerca illuminante sul trattamento riservato ai nativi americani in quell’epoca – scelte politiche ben precise che quindi perduravano ancora in quei giorni –, ma uscì in circa duecento copie e poi fu fatto sparire dalla circolazione. Il libro fu riesumato negli anni Settanta-Ottanta, ma sono stati davvero in pochi a leggerlo. Francis Jennings non era un antropologo di professione, dirigeva uno dei musei sui nativi americani, ma grazie al suo minuzioso lavoro di ricerca portò alla luce fatti inimmaginabili che ebbero un forte impatto sui movimenti sorti negli anni Sessanta, perché i tempi erano maturi per una riflessione seria su questi temi. Il clima era molto diverso da quando io ero ragazzino, negli anni Trenta e Quaranta. La mia famiglia era liberale e di sinistra, con un retroterra radicale, ma io giocavo con i miei amici nei boschi ai cowboy e agli indiani. Noi eravamo i cowboy che uccidevano gli indiani. Negli anni Sessanta e Settanta, tuttavia, le cose già cominciavano a cambiare. Nel 1969 mia figlia aveva dieci anni e una volta mi misi a curiosare tra i suoi libri di scuola. Uno si intitolava Exploring New England e raccontava la storia di quello Stato: i protagonisti erano un ragazzino e un anziano che lo guidava attraverso il New England. L’anziano signore illustrava al ragazzo tutte le cose meravigliose che erano state realizzate nella colonia. Mentre leggevo mi chiedevo: «Ora come se la caverà con la storia del massacro dei Pequot?», una strage orrenda in cui i colonialisti ammazzarono brutalmente tutte le donne e i bambini. La vicenda era descritta abbastanza bene, ma gli autori a un certo punto facevano dire al bambino: «Mi sarebbe piaciuto essere grande e trovarmi là». Voleva dire che se fosse stato là avrebbe massacrato donne e bambini, avrebbe cacciato gli indigeni e si sarebbe preso la loro terra. Lo mostrai a mia moglie, che ovviamente rimase scandalizzata e andò a parlare con l’insegnante, la quale le chiese qual era il problema. Mia moglie le mostrò il brano in questione, lei lo osservò attentamente poi rispose che non c’erano errori di grammatica! Non capiva proprio qual era il problema. Alla fine mia moglie le disse: «Secondo lei è giusto insegnare ai bambini queste cose? Soprattutto in un momento come questo, con il massacro di My Lai su tutti i giornali». L’insegnante rispose: «Be’, non tutti sono progressisti come voi». Insomma, a parecchi americani sta bene sterminare un popolo e prendersi la sua terra. Questo accadeva nel 1969, e non in qualche posto sperduto del sud rurale ma nel New England progressista.
Però oggi le cose sono cambiate, sono certo che non si trovano più manuali del genere e anche l’immagine dei nativi americani non è più la stessa. Lo stesso vale per la storia dello schiavismo, altrettanto censurata, anche se cominciano a comparire narrazioni più veritiere. Si è sempre dato per scontato, infatti, che con la fine della Guerra civile le cose migliorarono, che gli schiavi furono liberati e così via. Dunque il primo passo da fare è far sapere a tutti, al di fuori degli studi accademici, che dopo la soppressione formale della schiavitù essa fu di fatto ripristinata. Dieci anni dopo la Guerra civile, e dopo l’introduzione degli emendamenti alla Costituzione, Nord e Sud strinsero un patto che consentiva in pratica al Sud di ristabilire una specie di schiavitù criminalizzando l’esistenza stessa delle persone di colore: praticamente tutte le azioni compiute da un maschio nero adulto erano considerate illegali, ad esempio stare in piedi all’angolo di una strada, guardare una donna bianca e via dicendo. In men che non si dica le carceri si riempirono di uomini di colore, che divennero così un’ottima manodopera. Era molto meglio che possedere degli schiavi: di questi ti devi prendere cura perché sono una tua proprietà. Se invece attingi manodopera dalle carceri non te ne devi preoccupare, certamente non sciopererà né chiederà un aumento del salario. La rivoluzione industriale americana si è fondata per buona parte su questo. Una pratica che peraltro è andata avanti fin quasi alla Seconda guerra mondiale – ora si incomincia ad ammetterlo – e che ha degli elementi di affinità con la criminalizzazione della manodopera di colore sotto l’insegna della «guerra alla droga» di stampo razzista, che assunse i connotati attuali già al tempo della presidenza Reagan. Ma torniamo per un momento alla guerra in Vietnam, della cui dichiarazione è ricorso il cinquantesimo anniversario non tanto tempo fa. Quando scoppiò, mi misi a organizzare degli incontri per discutere del conflitto; parlavo nel salotto di qualcuno e venivano due o tre vicini, oppure in una chiesa, e anche lì non più di quattro persone. E quando, nei primi anni Sessanta, provai a tenere una conferenza al MIT sul Vietnam, dovemmo mettere insieme cinque o sei argomenti – Venezuela, Vietnam, Israele ecc. – per far partecipare una decina di persone. A Boston, la città più progressista del paese, il primo tentativo di organizzare una manifestazione pubblica nel parco del Boston Common – il luogo di ritrovo storico della città – fu nell’ottobre del 1965, in concomitanza con una giornata di protesta internazionale. Quella manifestazione fu boicottata con metodi violenti, soprattutto dagli studenti. Anch’io sarei dovuto intervenire, ma nessuno degli ospiti riuscì a parlare. L’unica ragione per cui non fummo aggrediti fisicamente era perché c’era parecchia polizia in giro; non che gli piacesse la manifestazione, ma le forze dell’ordine non volevano ritrovarsi dei morti ammazzati nel Boston Common. Il giorno dopo, il Boston Globe, un autorevole giornale progressista, anzi il più progressista del paese, pubblicò un editoriale al vetriolo contro i manifestanti insieme alla foto di un veterano ferito. La radio, intanto, mandava in onda a ripetizione invettive violentissime contro le attività criminali di coloro che osavano mettere in discussione il valore e la nobiltà d’animo dei nostri ragazzi andati a salvare il Vietnam. Poco prima mia moglie aveva portato le nostre due figlie ancora piccole a una manifestazione femminile a Concord, un comune tranquillo e con una lunga tradizione pacifista. Niente di che, stavano ferme con dei cartelli in mano. Le donne e anche le ragazze furono aggredite da una folla inferocita che lanciava lattine e pomodori. A cinque anni dall’inizio della guerra, nel marzo del 1966, fu organizzata un’altra giornata internazionale di protesta. Sapevamo che quella volta non avremmo potuto manifestare in pubblico così andammo in una chiesa. Persino la chiesa fu presa d’assalto, anche questa volta con lattine e pomodori, come sempre tra applausi scroscianti. Poi il clima cambiò, ma ci volle del tempo.
(Per gentile concessione di Ponte alle Grazie)





