 Un solo concerto in Italia; ma di quelli da ricordare e raccontare agli amici, se non ai nipoti. Perché lo show di Van Morrison, sabato a Brescia (data inaugurale del Brescia Summer Festival organizzato da D’Alessandro&Galli), pur in concomitanza con la finale di Champions League tra Juventus e Barcellona (o forse proprio per questo), è stato magnifico. La cornice era quella, straordinaria, di Piazza Loggia: luogo simbolo della Leonessa d’Italia e purtroppo della recente storia nazionale, amato e ricordato con sofferenza, al punto che talvolta dimentichiamo quanto è bello, e quanto è piacevole viverlo, oltre che guardarlo. C’erano le premesse per un grande evento, ma anche qualche timore legato al carattere di Morrison, che tornava nel nostro paese dopo sette anni di assenza: burbero, riottoso, al limite dello scontroso, poco o niente disponibile al contatto umano. D’altronde la ruvidezza dell’uomo è proverbiale, quasi quanto la sua voce.
Un solo concerto in Italia; ma di quelli da ricordare e raccontare agli amici, se non ai nipoti. Perché lo show di Van Morrison, sabato a Brescia (data inaugurale del Brescia Summer Festival organizzato da D’Alessandro&Galli), pur in concomitanza con la finale di Champions League tra Juventus e Barcellona (o forse proprio per questo), è stato magnifico. La cornice era quella, straordinaria, di Piazza Loggia: luogo simbolo della Leonessa d’Italia e purtroppo della recente storia nazionale, amato e ricordato con sofferenza, al punto che talvolta dimentichiamo quanto è bello, e quanto è piacevole viverlo, oltre che guardarlo. C’erano le premesse per un grande evento, ma anche qualche timore legato al carattere di Morrison, che tornava nel nostro paese dopo sette anni di assenza: burbero, riottoso, al limite dello scontroso, poco o niente disponibile al contatto umano. D’altronde la ruvidezza dell’uomo è proverbiale, quasi quanto la sua voce.
A posteriori, possiamo dire che il caratteraccio si è attenuato (anche se permane la bizzarria di fondo: arrivato nel pomeriggio con un jet privato, e in piazza pochi minuti prima delle 21, Morrison ha atteso le 20.59 in auto, con l’aria condizionata a tutta; quindi ha inviato sul palco la band e infine, allo scoccare dell’ora, si è presentato lui, con occhiali da sole, cappello Fedora in testa e abito scuro, il sax già pronto all’intro strumentale di Celtic Swing), mentre la voce – a poche settimane dal settantesimo compleanno – non ha perso nulla (anzi, forse ha pure guadagnato in morbidezza) dell’antico sp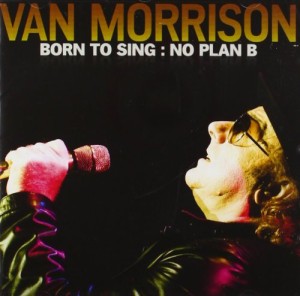 lendore. Se in passato qualcuno si stupiva che Van fosse nato bianco a Belfast, piuttosto che afro-americano sulle rive del Mississippi, appare ormai chiaro come il nostro sia un folletto dal pelo rosso uscito da qualche fiaba della sua terra, luogo di maghi, poeti, pescatori e musicisti. Uno che è cresciuto ascoltando Ray Charles, Solomon Burke,Huddie Leadbelly, James Brown; che poi ha cercato di imitarli; che infine è diventato un grande della musica, pari agli idoli di gioventù, se non migliore. Un tipo fuori dal comune che – come ha fatto capire con il titolo del suo penultimo album, Born To Sing: No Plan B del 2012 – è semplicemente nato e vissuto per cantare, e ha sempre cercato di farlo al meglio.
lendore. Se in passato qualcuno si stupiva che Van fosse nato bianco a Belfast, piuttosto che afro-americano sulle rive del Mississippi, appare ormai chiaro come il nostro sia un folletto dal pelo rosso uscito da qualche fiaba della sua terra, luogo di maghi, poeti, pescatori e musicisti. Uno che è cresciuto ascoltando Ray Charles, Solomon Burke,Huddie Leadbelly, James Brown; che poi ha cercato di imitarli; che infine è diventato un grande della musica, pari agli idoli di gioventù, se non migliore. Un tipo fuori dal comune che – come ha fatto capire con il titolo del suo penultimo album, Born To Sing: No Plan B del 2012 – è semplicemente nato e vissuto per cantare, e ha sempre cercato di farlo al meglio.
La voce di velluto ha giganteggiato in Brown-eyed Girl (la canzone che ne lanciò la carriera solista nel 1967, dopo gli esordi skiffle e blues con i Monarchs e i Them) e Days Like This, accarezzato come velluto nei duetti soul con la vocalist Dana Masters (Carrying a Torch e Some times We Cry), graffiato negli omaggi a B.B.King (Rock Me Baby, Early in the Morning), in cui ha perfino vinto l’abituale ritrosia e ha bofonchiato alcune parole di tributo al grande bluesman scomparso da poco. C’è stato anche il r’n’r degli inizi (la formidabile versione di Baby, Please Don’t Go, che a metà dei Sessanta fece conoscere l’originale, un antico blues di Big Joe Williams), il country (Here Comes A Night), molto jazz (compreso l’ennesimo, perfetto, arrangiamento di Moondance), l’irish folk. Com’era peraltro lecito attendersi da un musicista che ha sempre mescolato i generi più nobili, in un incastro di contaminazioni che ha arricchito la sua leggenda di cantante da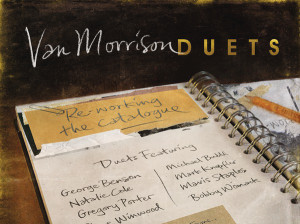 lla vocalità intrisa di negritudine, ma profondamente legato alle radici celtiche. Tra le righe, o meglio tra le parole e le note di un pezzo di rara sensibilità come In the Garden (del 1986), ora cantato con ritrovata leggerezza, si può ancora leggere lo smarrimento per lo scampato pericolo dopo cadute, depressioni, crisi mistiche, adesioni a sette e al fascino dei santoni: messaggio chiaro, come il titolo dell’album che lo contiene, No Guru, No Method, No Teacher. Conclusione praticamente scontata dopo un’ora e mezza abbondante di grande musica: tra l’ovazione del pubblico, pescando dal suo sterminato repertorio la gemma forse più preziosa, Van ha finito in …Gloria.
lla vocalità intrisa di negritudine, ma profondamente legato alle radici celtiche. Tra le righe, o meglio tra le parole e le note di un pezzo di rara sensibilità come In the Garden (del 1986), ora cantato con ritrovata leggerezza, si può ancora leggere lo smarrimento per lo scampato pericolo dopo cadute, depressioni, crisi mistiche, adesioni a sette e al fascino dei santoni: messaggio chiaro, come il titolo dell’album che lo contiene, No Guru, No Method, No Teacher. Conclusione praticamente scontata dopo un’ora e mezza abbondante di grande musica: tra l’ovazione del pubblico, pescando dal suo sterminato repertorio la gemma forse più preziosa, Van ha finito in …Gloria.


