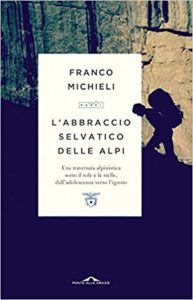 Oggi Franco Michieli è un geografo, esploratore e scrittore. Nato a Milano nel 1962 vive in Valcamonica. Fin da ragazzo ha deciso di dedicare l’esistenza a sperimentare e comunicare il rapporto intimo uomo-natura. Senza ombra di dubbio è tra gli italiani più esperti nel campo delle grandi traversate a piedi di catene montuose e terre selvagge. Dopo i percorsi integrali delle Alpi (81 giorni), dei Pirenei (39 giorni), della Norvegia (150 giorni) e dell’Islanda (33 giorni) compiuti da giovane, continua la ricerca del significato attuale dell’esplorazione, specie nelle terre artiche e sulle Ande, mettendo alla prova le proprie facoltà naturali di orientamento in assenza di Gps, strumenti ricetrasmittenti, mappe, bussola e orologio, mettendosi cioè nelle condizioni di un animale migratore o di un umano antico. Ora con lo splendido L’abbraccio selvatico delle Alpi – Una traversata alpinistica sotto il sole e le stelle, dall’adolescenza verso l’ignoto (Ponte alle Grazie, pag.320, euro 18) ritorna a quando tutto è iniziato. Estate 1981. Franco, terminato da qualche ora l’orale di maturità, si mette in cammino con l’amico Andrea. Portano il minimo dell’attrezzatura necessaria per poter affrontare qualsiasi tipo di ambiente: zaino, picca, cartine, abbigliamento estivo e invernale, sacco a pelo e un sottile sacco da bivacco. Niente tenda, niente fornelletto. L’obiettivo? La traversata delle Alpi, dal Mar Ligure all’Adriatico. Ad accompagnarlo, dopo Andrea, si alterneranno altri sette amici, fondamentali per la riuscita dell’impresa. 81 giorni, circa 2.000 Km, 219.000 metri di dislivelli, 25 cime tra le più significative della catena delle Alpi; gran parte dei pernottamenti bivaccando all’aperto o sotto ripari di fortuna. Un viaggio alpinistico, un’avventura tra amici, tante domande, tante scoperte…
Oggi Franco Michieli è un geografo, esploratore e scrittore. Nato a Milano nel 1962 vive in Valcamonica. Fin da ragazzo ha deciso di dedicare l’esistenza a sperimentare e comunicare il rapporto intimo uomo-natura. Senza ombra di dubbio è tra gli italiani più esperti nel campo delle grandi traversate a piedi di catene montuose e terre selvagge. Dopo i percorsi integrali delle Alpi (81 giorni), dei Pirenei (39 giorni), della Norvegia (150 giorni) e dell’Islanda (33 giorni) compiuti da giovane, continua la ricerca del significato attuale dell’esplorazione, specie nelle terre artiche e sulle Ande, mettendo alla prova le proprie facoltà naturali di orientamento in assenza di Gps, strumenti ricetrasmittenti, mappe, bussola e orologio, mettendosi cioè nelle condizioni di un animale migratore o di un umano antico. Ora con lo splendido L’abbraccio selvatico delle Alpi – Una traversata alpinistica sotto il sole e le stelle, dall’adolescenza verso l’ignoto (Ponte alle Grazie, pag.320, euro 18) ritorna a quando tutto è iniziato. Estate 1981. Franco, terminato da qualche ora l’orale di maturità, si mette in cammino con l’amico Andrea. Portano il minimo dell’attrezzatura necessaria per poter affrontare qualsiasi tipo di ambiente: zaino, picca, cartine, abbigliamento estivo e invernale, sacco a pelo e un sottile sacco da bivacco. Niente tenda, niente fornelletto. L’obiettivo? La traversata delle Alpi, dal Mar Ligure all’Adriatico. Ad accompagnarlo, dopo Andrea, si alterneranno altri sette amici, fondamentali per la riuscita dell’impresa. 81 giorni, circa 2.000 Km, 219.000 metri di dislivelli, 25 cime tra le più significative della catena delle Alpi; gran parte dei pernottamenti bivaccando all’aperto o sotto ripari di fortuna. Un viaggio alpinistico, un’avventura tra amici, tante domande, tante scoperte…

Per gentile concessione dell’editore Ponte alle Grazie pubblichiamo un estratto da L’abbraccio selvatico delle Alpi.
Nel lontano 1981, quando avevo 19 anni e abitavo in città, ma possedevo già un’insolita conoscenza della montagna, un paio d’ore dopo aver sostenuto l’esame orale di maturità partii per attraversare a piedi la catena delle Alpi dal Mar Ligure all’Adriatico. Con me c’era il mio compagno di banco Andrea, il primo di otto amici che senza precisi programmi mi avrebbero accompagnato ciascuno per una parte dell’avventura. Da una costa all’altra, per mesi, avrei camminato e scalato con loro dentro una sorta di altro mare, formato da quelle gigantesche onde pietrificate che sono le montagne, estese a perdita d’occhio. Un viaggio alpinistico che mi appariva necessario, direi indispensabile, per immergermi a lungo nell’ambiente e nel divenire della natura alpina e riuscire così a conoscere le reazioni reciproche – mie e degli eventi – capaci di nascere in quella convivenza. Volevo scoprire come e fino a che punto mi sarei adattato alla vita nomade in quota e quali sentimenti, emozioni, pensieri essa mi avrebbe suscitato; al tempo stesso desideravo vivere in attesa di qualche indefinibile segno di partecipazione da parte della montagna, che la mia devozione appassionata e permanente avrebbe potuto innescare. Ero un ragazzo, e come gran parte dei giovanissimi che stanno uscendo dall’adolescenza e dalle scuole superiori avevo bisogno di porre al mondo diverse domande. Percepivo una sorta di spazio vuoto, senza suolo su cui posare i piedi, tra me e il mondo degli adulti e del lavoro; non riuscivo a scorgere ponti che lo superassero né approdi adatti alla mia sensibilità. La verità è che le carriere professionali mi apparivano in gran parte corrotte, non rispetto alle leggi umane, ma nei confronti dell’equilibrio necessario alla prosperità della vita intera del mondo. Fin da bambino sentivo che l’arroganza dell’uomo nei confronti di tutte le altre creature è sconsiderata, e cercavo di immaginare una convivenza pacifica fra l’umanità, ogni altro vivente e la Terra. Intraprendere una professione «onesta» non avrebbe soddisfatto per nulla la mia esigenza, perché l’onestà tradizionale non tiene conto dei danni irreparabili che il comportamento delle civiltà umane provoca comunque all’intero, complesso e sensibile scenario della vita naturale, di cui facciamo parte senza averne chiara coscienza. Avevo assorbito dalla mia famiglia queste giuste convinzioni, assieme all’insegnamento di non adeguarmi mai al pensiero di massa e alle mode, ma di scegliere sempre con la mia testa. Idee che però in me si intensificavano tanto da farmi rifiutare ogni strada «normale». Ciò che cercavo non lo vedevo, era un’utopia, straordinariamente lontana. Eppure quella visione critica, in apparenza estremistica, si rivela oggi fondata: il processo di civilizzazione si è dimostrato davvero corrotto; il riscaldamento globale, il sovrasfruttamento delle risorse, le tensioni tra popoli impoveriti rispetto alle proprie aspettative, impongono la scelta tra una correzione drastica dei nostri modelli economici e culturali e una probabile estinzione di massa dei viventi. (…)

Come nasce l’idea di attraversare una catena montuosa? In realtà non nasce; semmai risuscita: questo tipo di esperienza è antico come la vita stessa. Milioni di specie vegetali e animali nel corso delle epoche hanno attraversato i continenti e tutti i loro ambienti, pianeggianti o montuosi. Negli ultimi milioni di anni lo stesso hanno fatto diverse specie del genere Homo, migrando a più riprese dall’Africa all’Eurasia e da qui nelle altre terre sparse per il globo, affrontando ogni genere di difficoltà e clima, adattandosi a condizioni multiformi, anche all’interno di sconfinate aree montuose. Prima che ogni civiltà iniziasse, i nostri predecessori avevano già acquisito tutte le abilità psicofisiche che in epoca moderna avventurieri e atleti mettono in mostra, credendo spesso di averle scoperte o innovate personalmente. Si tende a considerare l’alpinismo un’invenzione illuminista, collocata attorno all’anno 1786, quando il medico Michel Gabriel Paccard e il cercatore di cristalli Jacques Balmat raggiunsero la sommità del Monte Bianco, stimolati nell’impresa anche dall’ambizione del naturalista Horace-Bénédict de Saussure di ottenere misurazioni scientifiche eseguite sulla vetta. Ma si potrebbe per contro affermare che se non facessimo parte della famiglia delle grandi scimmie antropomorfe, cioè se milioni di anni fa i nostri antenati non fossero stati maestri d’arrampicata sugli alberi, e abituati a bivaccare su rami sospesi nel vuoto, l’epopea arrampicatoria moderna non ci sarebbe stata affatto, in barba alle idee dell’Illuminismo. Né saremmo in grado di inoltrarci fra i ghiacci del Monte Bianco o dell’Himalaya se durante le glaciazioni del Pleistocene due specie di Homo, i Sapiens e i Neanderthal, non si fossero incrociate e adattate a condividere con mammut e lupi i climi rigidi dell’Eurasia continentale. L’abitudine degli alpinisti di attribuirsi delle «prime» assolute quando scalano una montagna o una via si basa su uno sguardo che si esaurisce un po’ troppo vicino nel tempo. I pionieri dei secoli XVIII e XIX potevano esserne facilmente convinti a causa delle limitate conoscenze scientifiche e archeologiche dell’epoca, ma oggi si potrebbe ragionare diversamente. I nostri scalatori postmoderni potrebbero piuttosto riconoscere in certi gesti avventurosi un ritrovamento, una riscoperta di doti e relazioni che da secoli o millenni le società urbanizzate hanno dimenticato senza più immaginarne l’esistenza. Questi ritrovamenti esperienziali sono preziosi come tesori nascosti, e  certamente chi ne immagina l’esistenza e ne tenta la ricerca mostra di saper guardare più lontano di altri. Si potrebbe dire che compiere nella natura un’impresa originale rispetto alla propria epoca non significa essere «i primi», ma «gli ultimi» che riescono ad attingere a una realtà sepolta, a ridarle vita per rispondere a vuoti esistenziali del proprio tempo. Jack London chiamò questo processo «The call of the wild».
certamente chi ne immagina l’esistenza e ne tenta la ricerca mostra di saper guardare più lontano di altri. Si potrebbe dire che compiere nella natura un’impresa originale rispetto alla propria epoca non significa essere «i primi», ma «gli ultimi» che riescono ad attingere a una realtà sepolta, a ridarle vita per rispondere a vuoti esistenziali del proprio tempo. Jack London chiamò questo processo «The call of the wild».


