 Che i festival vivano al di là dei premi, oltre la giostra dei vincitori e dei vinti, è assolutamente vero. Ed è una fortuna. Anche perché è sempre più frequente il dissesto operato dalle giurie con premi improponibili, umorali e dilettanteschi, quando non assegnati in mala fede. L’Orso d’Oro a Touch Me Not di Adina Pintilie con cui la Giuria presieduta da Tom Tykwer ha chiuso la Berlinale 68 è un classico esempio di come un premio possa ricoprirsi di ridicolo: questa pretenziosa opera prima, a lungo coltivata dalla giovane regista rumena e infine portata a termine nella maniera peggiore possibile, è infatti un raro caso di film talmente sbagliato da esser riuscito a mettere d’accordo tutti su un giudizio nettamente negativo e per nulla preconcetto. Tutti tranne la Giuria, che per buona misura ha pensato bene di
Che i festival vivano al di là dei premi, oltre la giostra dei vincitori e dei vinti, è assolutamente vero. Ed è una fortuna. Anche perché è sempre più frequente il dissesto operato dalle giurie con premi improponibili, umorali e dilettanteschi, quando non assegnati in mala fede. L’Orso d’Oro a Touch Me Not di Adina Pintilie con cui la Giuria presieduta da Tom Tykwer ha chiuso la Berlinale 68 è un classico esempio di come un premio possa ricoprirsi di ridicolo: questa pretenziosa opera prima, a lungo coltivata dalla giovane regista rumena e infine portata a termine nella maniera peggiore possibile, è infatti un raro caso di film talmente sbagliato da esser riuscito a mettere d’accordo tutti su un giudizio nettamente negativo e per nulla preconcetto. Tutti tranne la Giuria, che per buona misura ha pensato bene di 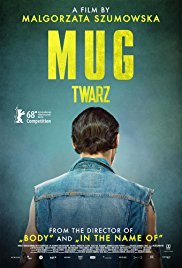 assegnare anche l’Orso d’Argento del suo Gran Premio al mediocre Mug (Twarz) della regista polacca Małgorzata Szumowska, anche questo, come il film della Pintilie, una storia che ruota attorno al rapporto disfunzionale tra corpo e persona nelle relazioni individuali. Tema che evidentemente la Giuria di Tykwer ha ritenuto degno di particolare attenzione nella social emergenza da hashtag me too che stiamo affrontando. Touch Me Not (che per buona misura ha vinto anche il Premio per la Migliore Opera Prima) è la messa a nudo teorica di una ricerca psicologica e spirituale che ha spinto la regista a lavorare per otto anni su una storia basata su una donna che cerca di superare la sua incapacità a farsi toccare dai partner: progetto altamente interessante (e molto sponsorizzato, va detto…), tra i più attesi di questa Berlinale, proprio per l’argomento, per le doti dimostrate nei suoi cortometraggi dalla giovane regista e per la lunga gestazione che ha avuto, eppure segnato da un esito finale fortemente discutibile, per pretenziosità intellettualistica, incapacità di trovare un dialogo concreto con lo spettatore, incoerenza strutturale e soprattutto per il rischio di cadere nella ricerca dell’effetto shock. Di fronte a tanta pretenziosità, l’Orso d’Argento a Mug di Małgorzata Szumowska fa quasi sorridere, trattandosi in questo caso di un mediocre film a tema in cui la regista abbozza un affresco sopra le righe della provincia polacca presa tra cattolicesimo di facciata e malafede relazionale: la storia è quella di un giovane operaio, il più figo del paese, che precipita nel vuoto dall’alto della gigantesca statua di Gesù che sta costruendo e finisce rifiutato da tutti perché si ritrova con la faccia di un altro trapiantata con successo.
assegnare anche l’Orso d’Argento del suo Gran Premio al mediocre Mug (Twarz) della regista polacca Małgorzata Szumowska, anche questo, come il film della Pintilie, una storia che ruota attorno al rapporto disfunzionale tra corpo e persona nelle relazioni individuali. Tema che evidentemente la Giuria di Tykwer ha ritenuto degno di particolare attenzione nella social emergenza da hashtag me too che stiamo affrontando. Touch Me Not (che per buona misura ha vinto anche il Premio per la Migliore Opera Prima) è la messa a nudo teorica di una ricerca psicologica e spirituale che ha spinto la regista a lavorare per otto anni su una storia basata su una donna che cerca di superare la sua incapacità a farsi toccare dai partner: progetto altamente interessante (e molto sponsorizzato, va detto…), tra i più attesi di questa Berlinale, proprio per l’argomento, per le doti dimostrate nei suoi cortometraggi dalla giovane regista e per la lunga gestazione che ha avuto, eppure segnato da un esito finale fortemente discutibile, per pretenziosità intellettualistica, incapacità di trovare un dialogo concreto con lo spettatore, incoerenza strutturale e soprattutto per il rischio di cadere nella ricerca dell’effetto shock. Di fronte a tanta pretenziosità, l’Orso d’Argento a Mug di Małgorzata Szumowska fa quasi sorridere, trattandosi in questo caso di un mediocre film a tema in cui la regista abbozza un affresco sopra le righe della provincia polacca presa tra cattolicesimo di facciata e malafede relazionale: la storia è quella di un giovane operaio, il più figo del paese, che precipita nel vuoto dall’alto della gigantesca statua di Gesù che sta costruendo e finisce rifiutato da tutti perché si ritrova con la faccia di un altro trapiantata con successo.

Molto migliore l’esito del paraguuaiano Las Herederas anche questo opera prima di Marcelo Martinessi, premiato sia per l’interpretazione della protagonista Ana Brun che con l’Alfred Bauer Prize per le nuove prospettive cinematografiche. Anche questa una storia di liberazione femminile costruita attorno alla relazione di lunga data che unisce due mature signore alle prese con le difficoltà economiche e la scoperta di nuove realtà esistenziali. L’Orso d’Argento per la regia al Wes Anderson di Isle of Dogs, presentato in apertura di festival, glorifica un vecchio amico della Berlinale (dove nel 2014 aveva vinto il Gran Premio della Giuria con Grand Hotel Budapest) e un autore già affermato ma forse non ancora segnalato con premi di rango. L’Orso d’Argento per 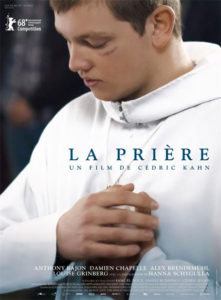 il migliore attore al giovane francese Anthony Bajon per La Prière di Cédric Kahn segnala un interprete misurato e promettente, mentre un po’ limitativo appare il premio per la pur ottima sceneggiatura di Museo a Manuel Alcalà e Alonso Ruizpalacios, che più di qualcuno dava tra i possibili favoridi di questa Berlinale. Al grande russo Alexey German Jr. di Dovlatov, infine, solo l’Orso d’argento per il contributo artistico assegnato a Elena Okopnaya per costumi e production design. Il grande sconfitto di questa Berlinale 68 resta dunque il cinema tedesco, soprattutto in considerazione del grande credito acquisito, a ragione, in un anno in cui praticamente tutte e quattro le opere tedesche in competizione si sono segnalate tra le migliori, sotto molteplici aspetti. Non passerà certamente inosservato il fatto che una giuria presieduta da un tedesco in un anno come questo non abbia saputo valutare adeguatamente la qualità di film come In the Aisles di Thobias Stuber, Transit di Christian Petzold, My Brother’s Name is Robert and He Is an Idiot di Philip Gröning e anche 3 Days in Quiberon di Emily Atef (che avrebbe meritato il premio per l’interpretazione alla brava Marie Bäumer nel ruolo di Romy Schnaider). La Berlinale diretta da Dieter Kosslick ha ancora un anno, il prossimo, prima di dover cambiare direzione e si presume rotta: le polemiche sulla successione, le lettere aperte degli autori, i tavoli pubblici di discussione qui a Berlino sono già ben attivi. L’esigenza di aggiustare il tiro in qualche misura c’è. Vedremo quel che ne verrà fuori.
il migliore attore al giovane francese Anthony Bajon per La Prière di Cédric Kahn segnala un interprete misurato e promettente, mentre un po’ limitativo appare il premio per la pur ottima sceneggiatura di Museo a Manuel Alcalà e Alonso Ruizpalacios, che più di qualcuno dava tra i possibili favoridi di questa Berlinale. Al grande russo Alexey German Jr. di Dovlatov, infine, solo l’Orso d’argento per il contributo artistico assegnato a Elena Okopnaya per costumi e production design. Il grande sconfitto di questa Berlinale 68 resta dunque il cinema tedesco, soprattutto in considerazione del grande credito acquisito, a ragione, in un anno in cui praticamente tutte e quattro le opere tedesche in competizione si sono segnalate tra le migliori, sotto molteplici aspetti. Non passerà certamente inosservato il fatto che una giuria presieduta da un tedesco in un anno come questo non abbia saputo valutare adeguatamente la qualità di film come In the Aisles di Thobias Stuber, Transit di Christian Petzold, My Brother’s Name is Robert and He Is an Idiot di Philip Gröning e anche 3 Days in Quiberon di Emily Atef (che avrebbe meritato il premio per l’interpretazione alla brava Marie Bäumer nel ruolo di Romy Schnaider). La Berlinale diretta da Dieter Kosslick ha ancora un anno, il prossimo, prima di dover cambiare direzione e si presume rotta: le polemiche sulla successione, le lettere aperte degli autori, i tavoli pubblici di discussione qui a Berlino sono già ben attivi. L’esigenza di aggiustare il tiro in qualche misura c’è. Vedremo quel che ne verrà fuori.



