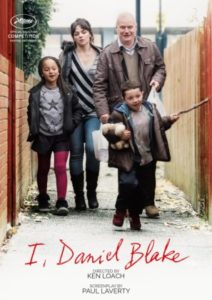 D’accordo, i premi sono solo premi. Ma, all’indomani della chiusura di Cannes 69, è davvero arduo non pensare che difficilmente la giuria di George Miller avrebbe potuto fare peggio. Il palmarès che è stato consegnato agli annali presta davvero un pessimo servizio a un’edizione del festival che invece sarà ricordata come una delle migliori da parecchi anni a questa parte, per la qualità complessiva della selezione e per la capacità di segnalare un cinema in via di rinnovamento. In ogni sezione non sono mancate le conferme di autori giovani al lavoro da qualche anno, così come le scoperte di personalità emergenti, a fronte di un pacchetto di presenze per così dire “di routine”, autori di cui “si conosce la canzone” e da cui si è avuto, nel bene e nel male, esattamente quello che ci si poteva aspettare. La Palma d’Oro a I, Daniel Blake di Ken Loach (probabilmente di compromesso, in una giuria incapace di trovare un accordo) va a segnalare quest’ultima opzione offerta da Cannes 69, la più inutile, o quanto meno residuale. Il che non fa certo un favore al Festival e ancor meno fa bene alla salute di un’industria cinematografica naturalmente in cerca di prospettive di rinnovamento e crescita, di cui Cannes (in coppia con Toronto) è ormai diventata uno dei due poli strategici indiscussi. La Palma d’Oro che Ken Loach torna a ritirare sulla Croisette, a dieci anni di distanza da quella vinta per Il vento che accarezza l’erba (cui si aggiungono gli altri quattro premi conquistati dall’inglese a Cannes nel corso degli anni), è una Palma inutile e retrodatata – per non dire retrograda – a prescindere dalla qualità di un film come I, Daniel Blake, che negli standard loach-lavertyani di riferimento non è nemmeno male.
D’accordo, i premi sono solo premi. Ma, all’indomani della chiusura di Cannes 69, è davvero arduo non pensare che difficilmente la giuria di George Miller avrebbe potuto fare peggio. Il palmarès che è stato consegnato agli annali presta davvero un pessimo servizio a un’edizione del festival che invece sarà ricordata come una delle migliori da parecchi anni a questa parte, per la qualità complessiva della selezione e per la capacità di segnalare un cinema in via di rinnovamento. In ogni sezione non sono mancate le conferme di autori giovani al lavoro da qualche anno, così come le scoperte di personalità emergenti, a fronte di un pacchetto di presenze per così dire “di routine”, autori di cui “si conosce la canzone” e da cui si è avuto, nel bene e nel male, esattamente quello che ci si poteva aspettare. La Palma d’Oro a I, Daniel Blake di Ken Loach (probabilmente di compromesso, in una giuria incapace di trovare un accordo) va a segnalare quest’ultima opzione offerta da Cannes 69, la più inutile, o quanto meno residuale. Il che non fa certo un favore al Festival e ancor meno fa bene alla salute di un’industria cinematografica naturalmente in cerca di prospettive di rinnovamento e crescita, di cui Cannes (in coppia con Toronto) è ormai diventata uno dei due poli strategici indiscussi. La Palma d’Oro che Ken Loach torna a ritirare sulla Croisette, a dieci anni di distanza da quella vinta per Il vento che accarezza l’erba (cui si aggiungono gli altri quattro premi conquistati dall’inglese a Cannes nel corso degli anni), è una Palma inutile e retrodatata – per non dire retrograda – a prescindere dalla qualità di un film come I, Daniel Blake, che negli standard loach-lavertyani di riferimento non è nemmeno male.

L’alternativa, che avrebbe permesso al festival di consolidare un’idea di cinema più consona ai tempi, era rappresentata di sicuro da Paterson di Jim Jarmush, film che spiccava nettamente sulla scena della competizione e che, fatta salva qualche eccezione eccellente (vedi Michel Ciment, che gli assegnava una sola stelletta nella classifica di Screen International, e i critici di Libération, che gliene davano appena due…), aveva incontrato il favore unanime sulla Croisette. La giuria è invece andata in direzione nettamente opposta, ignorando del tutto un film che rappresenta il punto di arrivo più maturo della carriera di Jarmush e si colloca in quella temperie estetica e cinematografica più solidamente contemporanea cui Cannes evidentemente mira e che, anzi, ambisce a determinare. A ciò si aggiunge l’imbarazzante ex aequo del premio per la regia, goffamente attribuito in evidente compromesso a Olivier Assayas, per il fantasmatico doppio sogno di Kristen Stewart in Personal Shopper, e al rum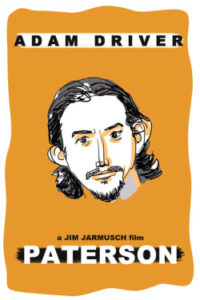 eno Cristian Mungiu per lo schematico Bacalaureat (nettamente meno interessante di Sieranevada di Cristi Puiu, a voler rimanere in territorio rumeno). Il Grand Prix a Xavier Dolan per Juste la fin du monde sembra d’altro canto rispondere a un copione che vede il canadese sempre ad un passo dal premio pieno: era successo due anni fa a Cannes con Mommy, cui era andato il Prix du Jury, e l’anno precedente a Venezia con Tom à la ferme, rimasto addirittura col solo premio Fipresci… Il doppio premio a Farushande – Le client di Asghar Farhadi (film sicuramente lucido e importante, anche se forse meno doloroso e travolgente di Una separazione e Il passato) risponde a uno schema festivaliero che non sembra ammettere deroghe in onore a un’autorialità da consolidare: il premio per la sceneggiatura era quasi obbligato, per un film che sembra anche troppo preciso nella scrittura, mentre quello per l’interpretazione maschile al suo protagonista Shahab Hosseini appare se non sbagliato, di sicuro sovracalibrato. Stessa cosa per l’interpretazione femminile, che è andata a premiare la filippina Jaclyn Jose per il solito film di Brillante Mendoza Mà Rosa: alternative migliori in questo caso non mancavano di certo, a iniziar
eno Cristian Mungiu per lo schematico Bacalaureat (nettamente meno interessante di Sieranevada di Cristi Puiu, a voler rimanere in territorio rumeno). Il Grand Prix a Xavier Dolan per Juste la fin du monde sembra d’altro canto rispondere a un copione che vede il canadese sempre ad un passo dal premio pieno: era successo due anni fa a Cannes con Mommy, cui era andato il Prix du Jury, e l’anno precedente a Venezia con Tom à la ferme, rimasto addirittura col solo premio Fipresci… Il doppio premio a Farushande – Le client di Asghar Farhadi (film sicuramente lucido e importante, anche se forse meno doloroso e travolgente di Una separazione e Il passato) risponde a uno schema festivaliero che non sembra ammettere deroghe in onore a un’autorialità da consolidare: il premio per la sceneggiatura era quasi obbligato, per un film che sembra anche troppo preciso nella scrittura, mentre quello per l’interpretazione maschile al suo protagonista Shahab Hosseini appare se non sbagliato, di sicuro sovracalibrato. Stessa cosa per l’interpretazione femminile, che è andata a premiare la filippina Jaclyn Jose per il solito film di Brillante Mendoza Mà Rosa: alternative migliori in questo caso non mancavano di certo, a iniziar e dalla Sonia Braga di Aquarius. Infine la questione Andrea Arnold con American Honey, film che per molti aspetti rappresentava nel concorso l’apertura di una prospettiva produttiva, estetica e autoriale innovativa: sarebbe stata l’occasione perfetta per una Palma d’Oro forse non pienamente centrata, ma di sicuro capace di lavorare in direzione di un cinema del futuro. Invece George Miller e i suoi hanno risolto la questione con il Premio della Giuria.
e dalla Sonia Braga di Aquarius. Infine la questione Andrea Arnold con American Honey, film che per molti aspetti rappresentava nel concorso l’apertura di una prospettiva produttiva, estetica e autoriale innovativa: sarebbe stata l’occasione perfetta per una Palma d’Oro forse non pienamente centrata, ma di sicuro capace di lavorare in direzione di un cinema del futuro. Invece George Miller e i suoi hanno risolto la questione con il Premio della Giuria.


