Abbiamo intervistato Emmanuel Carrère al t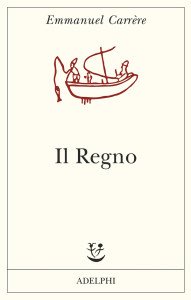 ermine della quattro giorni che il festival di Locarno ha dedicato allo scrittore-sceneggiatore-regista nel corso de “L’immagine e la parola”, l’evento primaverile durante il quale Carrère ha partecipato a confronti (con il regista Pawel Pawlikowski con cui ha intrecciato il proprio percorso in più di una occasione), workshop (sulla scrittura e sulla serialità), letture sceniche (deIl Regno, il suo ultimo romanzo, dalla sua viva voce e, nella traduzione italiana, da quella di Valeria Golino). “Da mesi faccio solo promozione del mio libro” racconta Carrère. “Raccontare d’altro, trovarmi su un terreno che non è il mio è molto rilassante. Ho potuto parlare di cinema, presentare i film che ho scelto (San Soleil di Chris Marker, Running on Empty di Sidney Lumet, Quién puede matar a un niño?per l’amato cinema di genere, ndr), attività che non sono legate al successo che devi garantire al libro. Quando Carlo Chatrian mi ha proposto una 4 giorni mi sono spaventato, che cosa vado a raccontare? mi dicevo. Ora è un peccato che sia finito.
ermine della quattro giorni che il festival di Locarno ha dedicato allo scrittore-sceneggiatore-regista nel corso de “L’immagine e la parola”, l’evento primaverile durante il quale Carrère ha partecipato a confronti (con il regista Pawel Pawlikowski con cui ha intrecciato il proprio percorso in più di una occasione), workshop (sulla scrittura e sulla serialità), letture sceniche (deIl Regno, il suo ultimo romanzo, dalla sua viva voce e, nella traduzione italiana, da quella di Valeria Golino). “Da mesi faccio solo promozione del mio libro” racconta Carrère. “Raccontare d’altro, trovarmi su un terreno che non è il mio è molto rilassante. Ho potuto parlare di cinema, presentare i film che ho scelto (San Soleil di Chris Marker, Running on Empty di Sidney Lumet, Quién puede matar a un niño?per l’amato cinema di genere, ndr), attività che non sono legate al successo che devi garantire al libro. Quando Carlo Chatrian mi ha proposto una 4 giorni mi sono spaventato, che cosa vado a raccontare? mi dicevo. Ora è un peccato che sia finito.
Tra le questioni che sono state toccate in questi giorni, c’è il rapporto tra realtà e finzione. Dei suoi due lavori da regista, il documentario Retour a Kotelnitch e il film tratto dal suo romanzo La Moustache (L’amore sospetto) lei è sembrato più soddisfatto del primo che del secondo.
I miei apprezzamenti di cinefilo sono egualmente distribuiti tra finzione e documentario. Non ho mai pensato che fossero due modi narrativi in opposizione. Semplicemente il documentario che ho fatto è secondo me un oggetto più originale, lo trovo più commovente, ci sono più legato, il film di finzione è ben realizzato, ma non direi che sia perfettamente riuscito. Le persone che ci hanno lavorato hanno fatto un buon lavoro, ma resta un film debole.
Se dovesse adattare un nuovo romanzo che errori non farebbe più.
Semplicemente non credo lo farei. Non ho voglia di fare un film di finzione, e di sicuro non da un mio libro. Preferirei allora andare nella direzione di qualcosa di più vicino al documentario. Ho chiesto che qui venisse proiettato Sans Soleil di Chris Marker, un film che amo e che ho visto molte volte. Guardandolo ancora una volta ho capito che se rifacessi del cinema vorrei andare in quella direzione: non ho il talento del cacciatore di immagini di Marker, ma l’associazione di riprese eterogenee mi attira molto più del cinema messo in scena che amo da spettatore, ma per il quale so di avere poco talento.
Direbbe che Sans Soleil è costruito come i suoi libri? Tra i diversi livelli di lettura e la voce off, assomiglia alla sua scrittura…
Se amo così tanto quel cinema credo sia perché sento una sorta di affinità profonda. Sono uomo più di scrittura che di immagine, ma trovo che in Sans soleil ci sia un perfetto equilibrio tra le due. Marker è decisamente il mio ideale di cineasta.
Il suo ultimo romanzo, Il Regno: che cosa ha fatto scattare in lei il desiderio di parlare di eventi intimi che si erano verificati molti anni prima?
In realtà la mia piccola storia personale di conversione, la mia crisi religiosa è subordinata a una sorta di visita guidata del Nuovo testamento che è invece il cuore del progetto. Certo, mi sono sentito legittimato a ritornare su quel periodo della mia vita, ma il vero soggetto del libro è il tentativo di comprendere l’enigma della fede che è all’origine del cristianesimo e il modo in cui sin dalle origini questo ha cominciato a prendere una forma letteraria. Il cristianesimo non è una dottrina, è una narrazione. Ho provato a indagare su chi fosse quel narratore, chi aveva scritto la prima biografia di Gesù.
 L’uscita del libro in un momento in cui la religione è al centro del dibattito sociale, politico, culturale mondiale, è stata particolarmente felice.
L’uscita del libro in un momento in cui la religione è al centro del dibattito sociale, politico, culturale mondiale, è stata particolarmente felice.
In realtà quando ho cominciato a lavorare al libro il contesto non era così caldo, ma durante tutta la scrittura ho sempre pensato che stavo affrontando una questione contemporanea, non ho mai pensato che stavo approntando un’opera su qualcosa di storico, senza legame con la nostra epoca.
Ha considerato nella fase delle ricerche la grande tradizione della letteratura cattolica francese, Mauriac, Bernanos, Malraux?
Non particolarmente, anche se amo molto quegli autori. Ho indagato piuttosto le radici storiche del cristianesimo, ho cercato di avvicinarmi alle origini e quindi di astrarre da tutto quello che c’è stato dopo. Oggi siamo abituati al cristianesimo come fenomeno culturale e religioso, ma se si prescinde dalla consuetudine, tutto quell’immaginario appare immediatamente come stravagante, folle. Ecco, ho cercato di tornare a quello stupore.
La sua posizione su Sottomissione di Houellebecq uscito quasi in contemporanea al Regno è stata molto chiara.
Ho difeso Houellebecq pubblicamente e penso molto bene di tutti i suoi libri. Non penso che lo scenario che prospetta in Sottomissione sia plausibile, ma non è quello il punto. Houellebecq è uno scrittore con una percezione acuta del momento storico in cui viviamo. Non penso solo all’Islam, ma a un momento più generale della storia umana. Stiamo vivendo una fase di mutazione e lui è lo scrittore che ne ha la visione più forte. Ogni volta la propone da un angolo diverso: turismo, Islam, clonazione, industria genetica, metamorfosi della sessualità, della famiglia. Può essere scioccante per come la racconta, ma è innegabile che abbia una straordinaria visione globale di un momento speciale della nostra civilizzazione.
Quali sono le regole di ingaggio che si dà quando affronta la narrazione di una vita che non è la sua?
Una regola che vale per tutti gli scritti e per tutti i film che partono dalla realtà e che parlano di altri, soprattutto se sono vivi, è non offenderli, non fare loro del male. In La mia vita come un romanzo russo ho trasgredito questa regola, raccontando la vicenda di mio nonno che mia madre mi aveva proibito di rivelare. Non ho rimorsi, perché ritengo che quella trasgressione sia stata salutare, ma non penso che uno scrittore abbia il diritto di fare quel che vuole nel nome del romanzo che deve produrre e spero di non trovarmi mai nella posizione di dover prendere una decisione simile.
 Forse la soluzione è quella suggerita da Sasha in Retour a Kotelnitch: l’ha autorizzata a parlare del dolore delle persone che aveva filmato perché si era reso conto che aveva portato il proprio in quel luogo e dentro il film.
Forse la soluzione è quella suggerita da Sasha in Retour a Kotelnitch: l’ha autorizzata a parlare del dolore delle persone che aveva filmato perché si era reso conto che aveva portato il proprio in quel luogo e dentro il film.
Vero, ma non basta. Perciò quando ho iniziato a scrivere il libro successivo, Vite che non sono la mia, un lavoro in cui raccontavo storie molto private, l’ho scritto sotto il controllo dei diretti interessati, stipulando con loro l’accordo che nulla sarebbe stato pubblicato senza il loro benestare e così è stato. C’è stato un momento molto commovente quando abbiamo letto il libro finito. E’ stato il movimento inverso rispetto ai libri precedenti, in cui ho messo le persone coinvolte di fronte al fatto compiuto. Ma in quei casi non poteva essere altrimenti.
Le è mai capitato che qualcuno le si proponesse esplicitamente come personaggio?
Nel caso di Vite che non sono la mia, uno dei personaggi principali l’ha fatto molto direttamente. Quando l’avevo incontrato la prima volta mi aveva raccontato la sua storia in maniera quasi teatrale, esponendosi per due ore, rivelando particolari molto intimi, mescolando malattia, handicap, giustizia. Alla fine del racconto, quando ci siamo detti arrivederci – e fino a quel momento lui non aveva mai manifestato di avermi riconosciuto come scrittore – mi dice: “Rifletta, credo che quello che le ho detto sia per lei”. Ci ho pensato per un paio di giorni, l’ho richiamato, abbiamo cominciato a vederci e a lui a raccontare. È stato come tratteggiare un ritratto su commissione. E io mi sono sentito a mio agio, come se il mio lavoro fosse stato legittimato da questa richiesta. In più era qualcuno con cui mi trovavo bene, qualcuno per cui ancora oggi nutro dell’amicizia e della stima. Insomma, un libro che parla di questioni serie e dolorose è stato scritto nella più grande serenità psicologica.
C’era poca serenità sul set di Les Revenants? Ha lasciato il lavoro alla sceneggiatura della serie dopo pochi episodi…
Mi è spiaciuto farlo, ma c’era troppa gente in tv che dava il proprio parere, trentenni con la barba di due giorni che sindacavano su ogni nostra scelta. Erano in perenne disaccordo tra di loro e c’era una totale mancanza di fiducia negli autori. Mi sono detto: “Non ho più l’età per sopportare una cosa simile”. Fabrice Gobert, che ne è l’autore, ha vent’anni meno di me, è in un momento della vita diverso, ha continuato a lavorare in quelle condizioni, ma quella è la sua opera, è pronto a sopportare, a battersi, a lavorare a una gestazione che è una guerra del Vietnam quotidiana, e fa bene a farlo. Ci sono cose legate ai momenti della vita. E poi io avevo voglia di tornare a scrivere il mio libro, quello che poi sarebbe diventato Il Regno. Rimpiango di essermene andato, ma sono contento di quel che ho portato agli episodi cui ho lavorato: la mia conoscenza di Philip Dick e la lentezza. La scrittura per la tv è frenetica, forse perché non si vuole annoiare lo spettatore, ma in realtà la narrazione è come il sesso, non si può andare troppo veloci. Li ho convinti a dilatare i contenuti del primo episodio su 3 perché era importante raccontare lo stupore di fronte all’inspiegabile (il ritorno in un villaggio di un gruppo di persone morte anni prima, ndr). E siamo riusciti a far appassionare gli spettatori della tv a un altro ritmo. La serie tv non è come il romanzo poliziesco dove si procede a gambe levate verso la fine il luogo in cui l’intrigo troverà la sua spiegazione. È piuttosto come una partita di scacchi. Le decisioni che prendi a ogni mossa precludono altre scelte future. E se a una serie di successo ne seguono altre 4 questo può essere un grosso problema.
Giovanna Bragana


