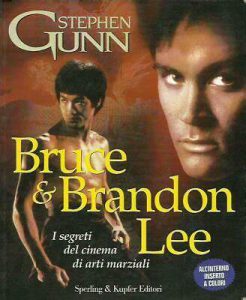 “Perché scrivere un saggio su questo argomento? Semplice. I film di arti marziali sono divertenti. Vi sembra poco?”
“Perché scrivere un saggio su questo argomento? Semplice. I film di arti marziali sono divertenti. Vi sembra poco?”
(da Bruce & Brandon Lee. I segreti del cinema di arti maziali, di Stephen Gunn. Sperling & Kupfer 1998)
Al di là di qualsiasi considerazione, Stefano Di Marino era uno che aveva ben chiare le regole. Quelle della scrittura innanzitutto, come testimonia il lascito di una produzione tanto prolifica quanto costante e diversificata. tantissimi i libri realizzati in un trentennio, con vari pseudonimi e abbracciando i vari sentieri dell’avventura, secondo un approccio onnicomprensivo che ha fatto muovere paragoni con i grandi narratori dell’Ottocento, Salgari in primis. Ma anche e soprattutto le regole dei generi. Che ha spiegato con dovizia di particolari nei suoi saggi, dedicati di volta in volta al cinema bellico, a quello di spionaggio o delle amate arti marziali. Una passione, quest’ultima che travalicava la pagina scritta, avendo lui praticato e insegnato tecniche di combattimento per anni, prima di renderle una costante dei suoi romanzi. Il bello in tutto questo era l’attitudine, non accademica, ma immersiva, entusiasta: leggere uno dei suoi saggi non significava soltanto comprendere la ramificata vastità di ogni genere, frutto di una conoscenza enciclopedica e puntuale, ma anche il precipitato emozionale e “appassionato” che queste storie erano in grado di rivelare. Il tutto grazie a una prosa essenziale, colloquiale nel senso migliore del termine, sempre coinvolta e mai scontata. Che – e questa è una grande lezione marziale – non cercava lo scontro ma l’armonia. Anche solo a leggere i post sul suo profilo Facebook (dove era altrettanto assiduo), ci si accorge in fretta di quanto Di Marino cercasse la mediazione fra il piacere e la qualità, forte di un divertimento per ciò che vedeva, che sopravanzava spesso quell’approccio un po’ snobistico dell’esperto che tende a scartare il più possibile. Nel cuore di Stefano Di Marino, al contrario, c’era spazio per tutto: viaggiatore assiduo nel mondo reale e in quello della fantasia, lasciava trasparire interesse tanto per il capolavoro quando per il B-movie, per il romanzo degli autori conclamati fino all’opera minore per il mercato dei paperback. Che poi, ironia ma neanche tanto del destino, era esattamente il target in cui il mercato l’aveva collocato.

Il che naturalmente rende difficile comprendere la portata del suo lavoro in un momento storico in cui l’editoria si misura sui numeri dei best-seller rilegati degli autori di grido. Probabile che lui stesso ne abbia avuto a soffrire, ma in un certo qual modo la figura dell’outsider gli si confaceva, del narratore “popolare” che scrive per un pubblico amante dell’avventura, quale presenza discreta ma puntuale e, ancora una volta, assidua delle edicole. Di qui, naturalmente, la collaborazione continuativa con le collane popolari di Mondadori, dal Giallo a, soprattutto, Segretissimo, dove ha tenuto banco per 25 anni con le avventure di Chance Renard, Il Professionista, destinato a restare il suo personaggio più famoso, firmato con il celebre pseudonimo di Stephen Gunn. Li è stato un po’ come uno sceneggiatore della Bonelli (con cui pure aveva collaborato saltuariamente) che segue una formula sempre fedele a sé stessa, ma in grado di variare per abbracciare tutti quei sentieri altrove elencati nella saggistica. Il che ha sempre fatto di questi romanzi pulp un’ottima palestra, in grado di garantire fidelizzazione, riconoscibilità e in cui Di Marino ha progressivamente trovato la sua dimensione. Anche se può essere facilmente dismessa quale clone povero di James Bond, l’epopea di Renard è qualcosa in più di un semplice bignami dello spionistico: è un enorme calderone di influenze dove l’intrigo si contamina con l’azione, passa per le arti marziali, insegue certe pulsioni esotiche da (ancora una volta) romanzo d’avventura ottocentesco, riflette una grande cultura dei generi cinematografici e diventa filone a sé. In cui la rigidità apparente dello schema fa rima con una grande libertà di movimento e dove, non a caso, un forte sapore d’antan si sposa con una visione moderna e persino avveniristica della narrazione all’italiana.
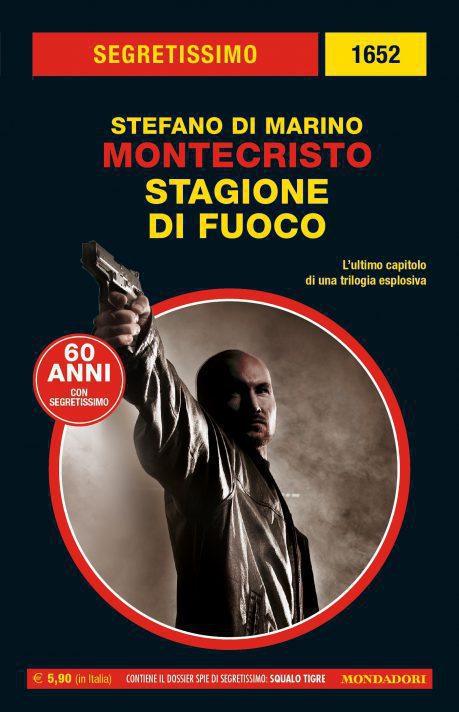
I romanzi di Stefano Di Marino, da questo punto di vista, sono quel grande film all’americana in salsa nostrana che il cinema ha troppo spesso evitato di fare. Pensiamo alla trilogia di Montecristo, in cui il riferimento a Dumas si sposa a una visione dell’Italia quale luogo di intrighi, colpi di stato mancati, terra di Nessuno degli equilibri internazionali degna delle nazioni di un Tom Clancy. L’avventura, insomma, non va cercata necessariamente lontano e in questo le opere di Di Marino hanno un sapore che al palese divertimento dell’invenzione unisce una vena più chiaroscurale, malinconica, quasi fossero un enorme what if di una creatività che si è trattenuta dal pensare in grande. Il racconto di un passato che non è stato e nemmeno lo è più narrativamente parlando (le sue sono storie rigorosamente di duri e al maschile, scevre da ogni relativismo contemporaneo). Lui in grande ha pensato davvero, ma con l’approccio onesto e il mestiere di quei creatori (quasi tutti gravitati attorno all’aria di Milano) che hanno sempre silenziosamente svecchiato le coordinate dei generi nostrani mentre in apparenza affastellavano storie solo per far distrarre, si pensi a Scerbanenco o al già citato Bonelli. La prematura scomparsa lascia orfani di un metodo e di opere già annunciate che sarà compito degli studiosi rimettere insieme e che crediamo permetterà ancora di  confrontarsi a lungo con la sua figura. Intanto l’ultima avventura di Chance Renard, Terra del fuoco, è ancora in edicola, mentre per dicembre Segretissimo ha già annunciato l’inedito Obiettivo sconosciuto, dove la malinconia promette inevitabilmente di essere ancora più forte del solito.
confrontarsi a lungo con la sua figura. Intanto l’ultima avventura di Chance Renard, Terra del fuoco, è ancora in edicola, mentre per dicembre Segretissimo ha già annunciato l’inedito Obiettivo sconosciuto, dove la malinconia promette inevitabilmente di essere ancora più forte del solito.


