 Il concerto di uno che è tornato dal regno dei morti, o che forse è semplicemente sopravvissuto a se stesso: questo è stato il live bolognese di Mark Lanegan. Infatti, se è vero da un lato che le scorribande distorte degli Screeming Trees, di cui era il leader indiscusso sulla scena grunge di Seattle, sono alle spalle (e con esse le incursioni elettriche dei Queens of the Stone Age, cui consentì il salto di categoria, e – almeno in quel momento – i duetti caramellosi con Isobel Campbell di Belle & Sebastian), Lanegan continua un suo personalissimo percorso che sembra dissonante anche dai musicisti che lo accompagnano nella sua carriera en solitaire.
Il concerto di uno che è tornato dal regno dei morti, o che forse è semplicemente sopravvissuto a se stesso: questo è stato il live bolognese di Mark Lanegan. Infatti, se è vero da un lato che le scorribande distorte degli Screeming Trees, di cui era il leader indiscusso sulla scena grunge di Seattle, sono alle spalle (e con esse le incursioni elettriche dei Queens of the Stone Age, cui consentì il salto di categoria, e – almeno in quel momento – i duetti caramellosi con Isobel Campbell di Belle & Sebastian), Lanegan continua un suo personalissimo percorso che sembra dissonante anche dai musicisti che lo accompagnano nella sua carriera en solitaire.
Non sono tanto i suoni in controtempo a colpire, né qualche stonatura disseminata qua e là, con la sezione ritmica costretta a fare i salti mortali per seguire le evoluzioni vocali di Lanegan, quanto il suo andare avanti diritto per una strada che è tutta sua, e che se ne frega di ciò che gli accade intorno. Con quella voce incredibile (anello di congiunzione tra Eddie Vedder dei Pearl Jam e Tom Waits), caricata oltre misura di sfumature catramose e oltreto mbali, Lanegan canta come sospeso in una atmosfera aliena da qualunque contaminazione. Lascia in un cantuccio la produzione solista degli anni Novanta (che è tuttavia la più bella, con album indimenticabili come The Winding Sheet, Whiskey For The Holy Ghost, Scraps At Midnight), per concentrarsi su quella del nuovo millennio, pescando in Field Song, Bubblegum, Heres Comes That Weird Chill e, soprattutto, in Blues Funeral (2012) e Phantom Radio (2014), magari condita con qualche spruzzo di Soulsavers (Revival) o di Screeming Trees (Black Rose Way): toni spettrali, andamento ipnotico, testi disperati, distorsioni sonore in serie.
mbali, Lanegan canta come sospeso in una atmosfera aliena da qualunque contaminazione. Lascia in un cantuccio la produzione solista degli anni Novanta (che è tuttavia la più bella, con album indimenticabili come The Winding Sheet, Whiskey For The Holy Ghost, Scraps At Midnight), per concentrarsi su quella del nuovo millennio, pescando in Field Song, Bubblegum, Heres Comes That Weird Chill e, soprattutto, in Blues Funeral (2012) e Phantom Radio (2014), magari condita con qualche spruzzo di Soulsavers (Revival) o di Screeming Trees (Black Rose Way): toni spettrali, andamento ipnotico, testi disperati, distorsioni sonore in serie.
Che poi a Lanegan non dispiaccia nemmeno una dimensione da crooner contemporaneo, lo dimostra l’album pubblicato nel 2013, Imitations, in cui rifà Sinatra, riprende addirittura classici come Autumn Leaves accanto a brani del repertorio grunge e indie di amici come Nick Cave o Greg Dulli (di cui a Bologna ha proposto The Deepest Shade, dal catalogo dei Twilight Singers). Si è molto discusso intorno a questo bizzarro album di cover: molti recensori hanno lamentato la apparente banalità di alcune scelte; i fans più accaniti paventavano una deriva commerciale.
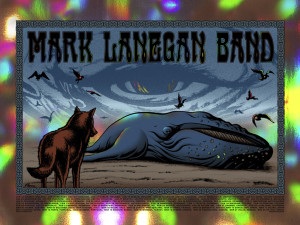 Credo che abbiano sbagliato su entrambi i fronti: ciò che realmente interessa a Lanegan è l’atmosfera, a cui sacrifica tutto il resto. E, infatti, quei brani – dal primo all’ultimo, senza eccezioni – sembrano suoi. Meglio, li rende decisamente suoi, conferendo loro un’impronta particolarissima. Così come personale è la scelta di non essere mai (!) illuminato da alcuna luce durante le sue esibizioni live: il viso è sempre in penombra, protetto dalla visione piena del pubblico, forse a nascondere le devastazioni di una vita di eccessi, forse a difendere una dimensione privata oppure per un sacro terrore della folla. In fondo, è il volto di uno che ha guardato nell’abisso e a cui l’abisso ha restituito lo sguardo, penetrandolo e rimanendogli dentro. Comunica con l’esterno garzie alla voce, anche se poi si sottrae alla conversazione e quando si rivolge al pubblico, quasi grugnendo, è secco, laconico, banale.
Credo che abbiano sbagliato su entrambi i fronti: ciò che realmente interessa a Lanegan è l’atmosfera, a cui sacrifica tutto il resto. E, infatti, quei brani – dal primo all’ultimo, senza eccezioni – sembrano suoi. Meglio, li rende decisamente suoi, conferendo loro un’impronta particolarissima. Così come personale è la scelta di non essere mai (!) illuminato da alcuna luce durante le sue esibizioni live: il viso è sempre in penombra, protetto dalla visione piena del pubblico, forse a nascondere le devastazioni di una vita di eccessi, forse a difendere una dimensione privata oppure per un sacro terrore della folla. In fondo, è il volto di uno che ha guardato nell’abisso e a cui l’abisso ha restituito lo sguardo, penetrandolo e rimanendogli dentro. Comunica con l’esterno garzie alla voce, anche se poi si sottrae alla conversazione e quando si rivolge al pubblico, quasi grugnendo, è secco, laconico, banale.
Al di là dei difetti (anche dell’impianto e dell’acustica approssimativa dell’Estragon) un concerto di Mark Lanegan si conferma, una volta di più, un evento eccezionale: c’è dentro condensata la storia di un movimento che da Seattle ha conquistato il mondo e lasciato tracce indelebili nella (miglior) musica contemporanea, c’è il dolore di vivere che qualcuno ha sopportato e porta in giro come un trofeo (lo stesso Lanegan) mentre altri (uno su tutti: Kurt Cobain) non ce l’hanno fatta. E, perché no, c’è dentro perfino un po’ di teatro ad accentuare il tutto, a deformarlo, a renderlo più gradevole. Come Lanegan canta in Methamphetamine Blues: “ I don’t want to live this heaven to soon…”. Ok, Mark: resta con noi a lungo…


