 «Questo libro è stato per me un regalo inaspettato. A Roma mi chiamano “l’alieno”». C’è stupore schietto e pudico orgoglio in Remo Rapino, abruzzese classe 1951, nel commentare l’attenzione critica e alla curiosità delle capitali e dei circoli dell’editoria nei confronti del suo secondo romanzo. Tra le sorprese editoriali dell’anno scorso grazie all’intuito dell’editor, lo scrittore Fabio Stassi, Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio (minimum fax, 2019, pp. 265, qui si può leggere la rassegna stampa) è racconto dal basso e dai margini, costruzione cesellata di uno Zelig di provincia, nato orfano di padre e in povertà nel 1926, che percorre in solitudine l’Italia e scavalca il secolo in osservazione, tra le altre cose, della rinascita postbellica (“il bum”), le lotte studentesche e del lavoro (“gli stremisti” coi “blugins”), l’ospedale psichiatrico:
«Questo libro è stato per me un regalo inaspettato. A Roma mi chiamano “l’alieno”». C’è stupore schietto e pudico orgoglio in Remo Rapino, abruzzese classe 1951, nel commentare l’attenzione critica e alla curiosità delle capitali e dei circoli dell’editoria nei confronti del suo secondo romanzo. Tra le sorprese editoriali dell’anno scorso grazie all’intuito dell’editor, lo scrittore Fabio Stassi, Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio (minimum fax, 2019, pp. 265, qui si può leggere la rassegna stampa) è racconto dal basso e dai margini, costruzione cesellata di uno Zelig di provincia, nato orfano di padre e in povertà nel 1926, che percorre in solitudine l’Italia e scavalca il secolo in osservazione, tra le altre cose, della rinascita postbellica (“il bum”), le lotte studentesche e del lavoro (“gli stremisti” coi “blugins”), l’ospedale psichiatrico:
“Lo scavacervello mio era il dottore Mattolini Alvise, con lui ho cominciato e con lui ho finito la mia avventura manicomiale, che all’inizio mi veniva da ridere quando ho sentito il suo nome per la prima volta, lui mi ha chiesto perché e io gli ho risposto perché in quella che era proprio come una città dei matti era giusto che il sindaco si chiamava proprio Mattolini, allora pure lui ha riso e ha detto Però mica sei tanto fuori, che poi pensavo che chi sta dentro si crede che gli altri matti stanno fuori e chi sta fuori si crede il contrario, ma non lo sapevo prima di quella volta”.
Un “cocciamatte” (“testa pazza”) dotato di spirito di osservazione, una visione primitiva e sognatrice sul mondo, capace di sintesi di saggezza inaspettate, che arrivano come lampi in un monologo quasi privo di punteggiatura. Scritto per guadagnare tempo sulla morte, mentre la si aspetta, come il cavaliere scacchista di Il settimo sigillo. Distillando e rielaborando una vita intera di lezioni, scritture, letture e incontri, l’autore fa confluire nel protagonista immaginario le vicende reali di molte persone a lui note (a volte prendendosi il rischio di agnizioni tra il pericoloso e il tragicomico). Affabulatore inarrestabile, da ex professore ma anche assiduo frequentatore di bar e di stadio (scuole linguistiche e di vita dichiarate), Rapino pubblica dal 1993 sia in prosa che in poesia. Anche per Rocco Carabba, la casa editrice fondata nel 1878 a Lanciano, la sua città. Minimizza gli accostamenti a Joyce per il flusso di coscienza del suo protagonista e a Gadda (ma anche Vincenzo Rabito e Andrea Camilleri) per l’invenzione lessicale e sintattica. Il suo è un inedito impasto linguistico dal sapore e dai suoni a volte comici, sempre antichi, quasi primordiali (chi scrive segnala “creapopolo” e “abbirrutato”). Fabrizio Gifuni, già esegeta dell’opera gaddiana, ne ha registrato l’audiolibro. Imbevuto di cinema e letteratura tanto quanto di storie di strada, Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio è stato semifinalista allo Strega e da placido irregolare prosegue il suo percorso gareggiando per il Campiello (premiazione a Venezia il 5 settembre) e il premio Napoli.
(Quella che segue è una sintesi delle dichiarazioni dell’autore nel corso di un incontro col pubblico avvenuto il 5 agosto 2020).
Chi è Liborio Bonfiglio
Quella di Liborio è una voce che cammina nella storia e che, raccontando se stessa, racconta la storia di un secolo, gli eventi tra il Novecento e i primi anni del terzo millennio. Liborio nasce per la prima volta nel ’98, come protagonista di una serie di poemetti pubblicati dalla Mobydick di Guido Leotta di Faenza. Lì figurava come muratore, un personaggio che per una serie di disgrazie perde quasi l’uso della parola ed entra in quello che lui chiama “il silenzio più silenzio di tutti”, cioè il silenzio dei matti, sostenendo che questo è avvenuto per la morte di Togliatti. Anni fa una giuria molto qualificata, formata anche da Giuseppe Pontiggia e Michele Prisco, mi suggerì che Liborio funzionava, come voce della provincia, e mi spinse a svilupparlo. Dopo qualche anno ho cominciato a lavorarci sopra. Fuori margine, il mio libro precedente, era una carrellata di una ventina di personaggi reali che avevo rintracciato nella mia città, all’interno di una ricerca iniziata tempo fa con Repertorio dei pazzi della città di Palermo di Roberto Alajmo, che si pose una domanda precisa: in ogni città abbiamo liste, elenchi di musei, personaggi, parchi, cattedrali, piazze, scuole, perché non abbiamo una lista dei matti? Da qui la casa editrice Marcos y Marcos sviluppò una collana sui matti delle città, e io lavorai sui matti di Lanciano (città mai citata, ma riconoscibile come luogo in cui è ambientato il suo ultimo romanzo, ndr), perché ce ne stavano tanti. Tra loro c’era anche “Libbo’, col nome troncato”. In seguito è diventato il protagonista del romanzo e allora mi sono posto il problema di come farlo parlare. Ho pensato che la cosa migliore sarebbe stata renderlo il più possibile autonomo, ascoltarne la voce. C’è un verso molto significativo di una canzone di Fabrizio De André, Il matto del villaggio, ripresa dall’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, che racconta la storia di Frank Drummer. Dice: “Tu prova ad avere un mondo nel cuore / e non riesci ad esprimerlo con le parole / E la luce del giorno si divide la piazza / tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa”. Io mi sono messo su quel lato della piazza, per ascoltare questa voce. E quindi di conseguenza farlo parlare di sé. Una vita come tante, la sua. Liborio ha un nome che a me è piaciuto perché ha la stessa radice di “libertà”. È un personaggio inventato ma i fatti che gli accadono sono tutti reali, tutti accaduti ad altre persone. Da quelli più quotidiani a quelli che lui chiama “i segni neri” o le risposte ai segni neri, “le cattiverie rivoltose”. Si tratta di cose accadute a mio padre o a me, durante il servizio militare, o gli anni passati a Bologna… Tutto quello che accade lo faccio accadere a lui, dalla nascita fino all’anno in cui si prepara a entrare in scena la morte: il fascismo, la guerra, l’ottobre del 1943 visto da un ragazzo di diciassette anni che ha il rimpianto di non aver partecipato a quei giorni di resistenza. Fino all’operaio della Borletti, a cui il rumore delle pedaliere entra nel cervello, facendolo diventare un “cocciamatte”.

Elio Petri e García Márquez
A Santa Maria di Leuca ho avuto occasione di parlare a lungo con gli altri finalisti dello Strega. Una sera Sandro Veronesi ci ha raccontato che secondo lui lo scrittore, come un giocatore di calcio, ha bisogno di un allenatore. Ci sono scrittori che non sanno quello che possono dare, soprattutto quelli che non sono consapevoli dei propri limiti. Ma quando un calciatore lo è, ci vuole qualcuno che lo aiuti a superarli e ad aiutarlo, a diventare altro da quello che è, a completare ciò che sta facendo. Ha portato esempi concreti, come il proprio, dicendo che quando è consapevole dei suoi limiti, chiede aiuto agli altri: ai grandi scrittori, al cinema, alla musica, e così via. Allora per correttezza e sincerità vorrei dire che l’esperienza di Liborio del carcere e del manicomio, quando viene preso per matto, è una vicenda che mi è tornata in mente dalla visione di La classe operaia va in paradiso di Elio Petri, da poco restaurato. La mia generazione è stata molto fortunata, lo devo dire, ha vissuto anni molto intensi, si è formata su grandi opere, anche di cinema. Ricordo benissimo Lulù Massa (Gian Maria Volonté) che va a trovare il compagno Mitilina (Salvo Randone) in manicomio, che gli dice più o meno: “io non sono matto, volevo solo sapere che cosa facevano del mio lavoro”. È un discorso molto interessante sul lavoro, l’alienazione e la mercificazione dell’uomo. Un altro grande aiuto mi è venuto da un libro a me molto caro, L’amore ai tempi del colera di Gabriel García Márquez, il cui protagonista, Florentino Ariza, riesce a coronare il suo sogno d’amore soltanto intorno ai settantacinque anni. Liborio, allontanato dalle vicende della vita dal suo grande amore, alla fine riesce a riconquistare la donna che ama – certo, regalandole fiori sottratti alle tombe del cimitero… – dopo aver aspettato sessant’anni. Così è nato Liborio e si è sviluppato in un catalizzatore, la figura simbolo di un senza voce, di un ultimo della fila, che vive in una periferia esistenziale, oltre che geografica. Ho camminato con lui per qualche tempo, per qualche spazio della piazza, poi l’ho seguito, di spalle mentre lui parlava, parlava…
Una lingua meticciata
Liborio avrebbe potuto scrivere la sua vita soltanto nello stesso modo in cui pensava e parlava. Una lingua meticciata, in chiaroscuro, con parole gergali, tratte dal quotidiano, dialettismi, che hanno colpito anche i critici non abituati. In coda al libro ho messo un glossario – con termini come “micuriccio” (“muffa”), o “abbottarsi” (“riempirsi”) – ma alla fine ho saputo che l’hanno usato in pochissimi. Diego Da Silva è rimasto colpito dalla parola “addosolare”, che vuol dire farsi ascoltare, farsi sentire. In certi casi sono addirittura parole lontane di secoli, che non si usano più. La lingua di Liborio è sgrammaticata, quella di chi non conosce l’italiano ma che volendo scrivere un libro vuole parlarlo per forza. Il pazzo, poi, ha la caratteristica psicologica di ripetere spesso le parole, perché vuole farsi ascoltare, sentire, dire “ci sono anch’io” all’interno della comunità. Come se avesse paura di non essere ascoltato.
Meraviglia e amore
Ho insegnato per circa quarant’anni filosofia e storia nei licei e sono sempre rimasto colpito dall’idea di meraviglia come origine della filosofia, come scriveva Aristotele nel primo libro della Metafisica. Liborio è un personaggio che si stupisce, che cerca, un po’ come il Siddharta. Vive tra stupore e dolore. In lui c’è un’anima filosofica, anche se inconsapevole. Si chiede il perché delle cose. Una figura di “storia della marginalità”, quella che racconta, ad esempio, la Storia medievale attraverso un mugnaio, un contadino. Un eroe senza lapide, non avrà mai una piazza dedicata ma rappresenta nella storia uno spazio bianco, che è fondamentale, all’interno della pagina, perché permette di leggere tra i caratteri neri. Sogna, è infelice, ma non vuole essere felice come gli altri. Si definisce un “fiommista” (cioè iscritto al sindacato più antico, la FIOM, quello degli operai metallurgici, ndr). Quanti hanno fatto il viaggio dell’emigrazione come lui? Oggi in Italia tendiamo a dimenticarlo ma nei primi decenni del Novecento ben tredici milioni di italiani sono andati all’estero. Lo siamo ancora oggi, emigranti. È un “io” che tende a diventare “noi”, una voce individuale che vuole farsi coro. Ho inteso questo romanzo come un grande libro d’amore. Ho voluto che mettesse al centro l’esigenza dell’accoglienza del diverso, della neurodiversità. Man mano che va avanti negli anni Liborio si rende conto che la sua vita è fatta di segnali negativi, a cui deve corrispondere la ribellione, il “segno nero”. Le sue sono “cattiverie rivoltose” di poco conto, ma sono comunque segni di libertà, di una presa di coscienza. Un libro d’amore perché è un libro di porti aperti e non di muri alzati, di dialettica dell’inclusione. Al premio Campiello un giornalista, per necessità di sintesi, scrivendo dei finalisti ha trovato per ognuno di noi un aggettivo: Francesco Guccini era il “malinconico”, Patrizia Cavalli “l’attesa”, Ade Zeno “l’inquieto”, Sandro Frizziero “il chioggiotto”. Io ero “l’inclusivo”. Mi ha fatto molto piacere essere definito così, proprio nella patria della Lega.
Pacifismo e follia
L’antimilitarismo del romanzo viene dal mio tentativo di comprendere, attraverso soprattutto i racconti orali delle persone che hanno vissuto gli anni della guerra (nel 2011 Rapino ha scritto per la casa editrice Rocco Carabba I ragazzi che dicevano okay, sui “martiri ottobrini” della rivolta lancianese del 1943, ndr). Credo che il desiderio di pace nasca dall’aver vissuto la guerra, dall’aver visto allora le brutture più terribili a cui un uomo possa assistere. La prima espressione di pacifismo in Liborio nasce quando, finita la guerra, viene chiamato a fare il servizio militare: non riesce a capire il senso di quella chiamata. La guerra è qualcosa di molto complesso e Liborio inconsapevolmente sogna un mondo di pace, nella vita come nel lavoro. Lo vedo come una figura tra Don Chisciotte e Forrest Gump, con gli stessi fantasmi e la stessa ingenuità. In un libro molto bello di Walter Mauro, La letteratura è un cortile, pieno di personaggi, si dice che la letteratura ha il compito di stare in quella parte della piazza di cui parla la canzone di De André. In questo cortile Liborio è l’ultimo arrivato, con la sua follia, che a volte può esprimere un’energia 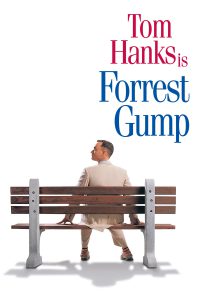 che mette in discussione i codici sociali dominanti. Michel Foucault dice che la follia nasce in Occidente e non prima del Cinquecento, quando i vecchi lebbrosari diventano manicomi. E chi va, allora, in manicomio? Il vagabondo, il povero, l’eretico, chi non produce, non lavora, non riconosce i valori della borghesia, il profitto. Prima, il folle era ancora accettato. Non faccio i nomi ma nella mia città c’è un matto, che diceva di un altro matto: “se fosse miliardario non sarebbe pazzo, ma eccentrico”.
che mette in discussione i codici sociali dominanti. Michel Foucault dice che la follia nasce in Occidente e non prima del Cinquecento, quando i vecchi lebbrosari diventano manicomi. E chi va, allora, in manicomio? Il vagabondo, il povero, l’eretico, chi non produce, non lavora, non riconosce i valori della borghesia, il profitto. Prima, il folle era ancora accettato. Non faccio i nomi ma nella mia città c’è un matto, che diceva di un altro matto: “se fosse miliardario non sarebbe pazzo, ma eccentrico”.


