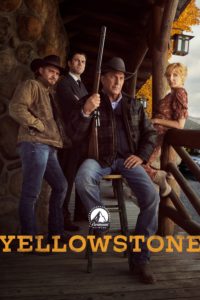 Da più parti l’integrità della figura attoriale di Kevin Costner, così autenticamente legata ai solidi valori americani di rettitudine, rispetto dell’altro e delle regole e quindi assoluto rispetto delle tradizioni e sensibilità particolare nei confronti dell’umanità sconfitta, memoria storica come archivio al quale attingere, viene paragonata e con una buona dose di verità a quella di Clint Eastwood del quale sembra avere raccolto sotto molti profili il testimone, nonostante l’attività del grande vecchio di Hollywood continui, macinando storie e racconti per un’America che non ha più il desiderio di sognare i propri eroi. Il suo cinema più recente sta riscrivendo i fatti di quel passato, facendo rivivere i suoi eroi, ma questa, come si dice, è un’altra storia. È Un mondo perfetto del 1993 il film che sicuramente mette in luce con evidenza le loro affinità elettive. Un racconto che resta una delle cose più belle che il cinema degli ultimi anni ci abbia regalato, ma soprattutto un film che sintetizza alla perfezione sia la simbiosi tra queste due figure di una Hollywood ormai sempre più appartata che i due rappresentano, sia quell’idealizzazione del mondo filtrato e governato da una attenzione e protezione paterna. Quella eterna paternità cara ad entrambi, quel paterno calore, fosse anche distante, che quando manca disorienta erodendo i principi fondanti della convivenza. Il tema della paternità, strettamente legato a quelle delle regole, di una innata disciplina, è una costante assoluta del cinema di Eastwood, basta scorrere la sua filmografia per ritrovarne copiose tracce. Riflessioni che sanno toccare la sfera personale dei suoi personaggi, ma con la chiara intenzione e il visibile progetto di diventare temi per considerazioni più generali che riguardino ad esempio la perduta paternità della Nazione, punto di riferimento costante del cinema dell’autore californiano e sua linea di confine dentro la quale ha segnato la sua presenza nel mondo del cinema. Un film su tutti, nel quale sintetizza alla perfezione questa ambivalenza della paternità è sicuramente Potere assoluto del 1997.
Da più parti l’integrità della figura attoriale di Kevin Costner, così autenticamente legata ai solidi valori americani di rettitudine, rispetto dell’altro e delle regole e quindi assoluto rispetto delle tradizioni e sensibilità particolare nei confronti dell’umanità sconfitta, memoria storica come archivio al quale attingere, viene paragonata e con una buona dose di verità a quella di Clint Eastwood del quale sembra avere raccolto sotto molti profili il testimone, nonostante l’attività del grande vecchio di Hollywood continui, macinando storie e racconti per un’America che non ha più il desiderio di sognare i propri eroi. Il suo cinema più recente sta riscrivendo i fatti di quel passato, facendo rivivere i suoi eroi, ma questa, come si dice, è un’altra storia. È Un mondo perfetto del 1993 il film che sicuramente mette in luce con evidenza le loro affinità elettive. Un racconto che resta una delle cose più belle che il cinema degli ultimi anni ci abbia regalato, ma soprattutto un film che sintetizza alla perfezione sia la simbiosi tra queste due figure di una Hollywood ormai sempre più appartata che i due rappresentano, sia quell’idealizzazione del mondo filtrato e governato da una attenzione e protezione paterna. Quella eterna paternità cara ad entrambi, quel paterno calore, fosse anche distante, che quando manca disorienta erodendo i principi fondanti della convivenza. Il tema della paternità, strettamente legato a quelle delle regole, di una innata disciplina, è una costante assoluta del cinema di Eastwood, basta scorrere la sua filmografia per ritrovarne copiose tracce. Riflessioni che sanno toccare la sfera personale dei suoi personaggi, ma con la chiara intenzione e il visibile progetto di diventare temi per considerazioni più generali che riguardino ad esempio la perduta paternità della Nazione, punto di riferimento costante del cinema dell’autore californiano e sua linea di confine dentro la quale ha segnato la sua presenza nel mondo del cinema. Un film su tutti, nel quale sintetizza alla perfezione questa ambivalenza della paternità è sicuramente Potere assoluto del 1997.

Per Costner le cose si manifestano più o meno con la stessa modalità nonostante la ridotta attività autoriale rispetto a quella di Eastwood. Nei tre titoli che compongono la sua filmografia da regista, Costner conferma le similitudini dei percorsi artistici con il suo più anziano collega. Balla coi lupi del 1990, L’uomo del giorno dopo del 1997 e Terra di confine – Open range del 2007, sono esempi della ricerca che l’attore-regista ha compiuto non solo nella memoria cinematografica del suo Paese, adottando il western come canone interpretativo del presente e canone fondante dei rapporti umani e delle società, immaginando con un ottimismo stemperato da una costante malinc onia, quella rifondazione del tessuto sociale e umano americano che volga lo sguardo verso i valori antichi della sua costituzione. L’uomo del giorno dopo è un magnifico sogno radicato nel presente e che in quel presente si sente inadeguato, provando, insieme all’amore per l’America, un desiderio di risolutivo rinnovamento che non sembra potere avvenire come nelle comunità primitive, se non con la solidarietà del dopo catastrofe. In fondo è lo stesso sostrato che sorregge da sempre il cinema di Eastwood declinato in più varianti, perfino quando, con la durezza di uno sbirro senza pietà impugnava la sua 44 magnum. Nonostante questo cinema – quello eastwoodiano e sigeliano di Callaghan – abbia rappresentato una reazione nostalgica, autoritaria e poliziesca e quindi sostanzialmente reazionaria delle società, in un periodo in cui le istanze libertarie partivano proprio dalle Università occidentali, con il trascorrere del tempo e il lavoro di regia questo approccio si è modificato, tanto che i suoi fans più entusiasti si annoverano in quella parte liberal del pubblico e della critica. Tutto è avvvenuto nonostante, comunque, quel cinema, abbia conservato i tratti di una dirittura morale inflessibile, ma stemperata dalla considerazione dell’altro e quindi da una rilettura dei rapporti sociali e della convivenza collettiva. Titoli come Debito di sangue, Gran Torino o ancora Fino a prova contraria segnano l’approccio differente che il cinema di Eastwood ha saputo offrire, dopo gli scenari brillanti, ma reazionari del suo lavoro d’attore negli anni ’70 e ’80.
onia, quella rifondazione del tessuto sociale e umano americano che volga lo sguardo verso i valori antichi della sua costituzione. L’uomo del giorno dopo è un magnifico sogno radicato nel presente e che in quel presente si sente inadeguato, provando, insieme all’amore per l’America, un desiderio di risolutivo rinnovamento che non sembra potere avvenire come nelle comunità primitive, se non con la solidarietà del dopo catastrofe. In fondo è lo stesso sostrato che sorregge da sempre il cinema di Eastwood declinato in più varianti, perfino quando, con la durezza di uno sbirro senza pietà impugnava la sua 44 magnum. Nonostante questo cinema – quello eastwoodiano e sigeliano di Callaghan – abbia rappresentato una reazione nostalgica, autoritaria e poliziesca e quindi sostanzialmente reazionaria delle società, in un periodo in cui le istanze libertarie partivano proprio dalle Università occidentali, con il trascorrere del tempo e il lavoro di regia questo approccio si è modificato, tanto che i suoi fans più entusiasti si annoverano in quella parte liberal del pubblico e della critica. Tutto è avvvenuto nonostante, comunque, quel cinema, abbia conservato i tratti di una dirittura morale inflessibile, ma stemperata dalla considerazione dell’altro e quindi da una rilettura dei rapporti sociali e della convivenza collettiva. Titoli come Debito di sangue, Gran Torino o ancora Fino a prova contraria segnano l’approccio differente che il cinema di Eastwood ha saputo offrire, dopo gli scenari brillanti, ma reazionari del suo lavoro d’attore negli anni ’70 e ’80.

È proprio il western il solco che segna la tradizione sia per Eastwood (Il cavaliere pallido, Gli spietati…), sia per Costner. La conferma per quest’ultimo ci viene dalla recente serie TV in onda su Sky e ancora disponibile on demand, di cui Costner, oltre che protagonista è anche produttore. La prima stagione della serie, non si discosta dai canoni di un western che oggi conosciamo e il suo scenario ci aiuta a completare la riflessione sul percorso artistico dell’attore-autore che resta uno degli ultimi depositari di quella cultura antica e autentica che sa coniugare una profonda umanità di sguardo sul mondo con una inflessibilità nei giudizi. Il personaggio del west è stato sempre un caparbio, refrattario ad un calcolo di convenienza. Con Yellowstone Costner affida al presente e al futuro quel mondo pronto a scomparire o forse già scomparso e di cui Yellowstone è solo il simulacro vuoto. È forse lo spettatore ad essere chiamato a questo incarico di affidatario di questa delicata consegna. Quello stesso spettatore per il quale il western ha saputo disegnare non solo i paesaggi dell’immaginario (magari con John Ford), ma anche quelli interiori, inventando la nuova e, se si vuole, infantile epopea del cavaliere invincibile senza macchia e senza peccato.

Ma Yellowstone sembra lavorare sui residui di un’epica conclusa, su ciò che resta dell’epoca d’oro dei cowboys, là dove l’iconografia e il gergo restano archetipi malinconici e solo replicati. Purtroppo, quel poco che resta è anche corrotto, infettato dai soldi, dal potere, dal malaffare e l’infezione ha toccato perfino l’antica e proverbiale saggezza indiana. Oggi Birmingham, il capo delle tribù della riserva con cui Dutton ha a che fare, è solo un altro spregiudicato affarista che adotta gli stessi intrallazzi dei bianchi e il loro pensiero e linguaggio per fare soldi con il suo progetto volto a realizzare un casinò nella riserva. Yellowstone è un ranch nel Montana che appartiene da oltre cento anni alla famiglia Dutton, John è l’ultimo della stirpe e ha quattro figli: Jamie e Beth sono avvocati, Kayce si è allontanato dalla famiglia a causa del suo insanabile dissidio con il padre e ha sposato una donna indiana, un altro fa il cowboy e bada all’allevamento. È Beth la più spregiudicata ed è anche quella che ha le maggiori affinità con il padre. Il ranch rischia di essere assorbito da una speculazione messa in piedi dagli indiani della riserva, in combutta con un affarista che è sull’orlo del baratro. Vari guai mutano la vita della famiglia, malattie e incomprensioni, incidenti, vecchie ruggini e guai legali non mancano. Su queste coordinate corre il disfacimento di un’epoca che in fondo Yellowstone rappresenta. Ma Yellowstone è soprattutto un film su una difficile e ingestibile paternità, quella di Costner che ha smesso di essere il figlio di una memoria che sa farsi presente, come accadeva in L’uomo dei sogni. Sono passati parecchi anni da quel memorabile film, e oggi il padre è lui. Ma sono anche mutati i tempi, si sono impoverite le relazioni, di pari passo con il crescere del benessere. È così che il racconto diventa, in controluce, anche la narrazione di un fallimento, di un amaro e finale fallimento, di una paternità tutta declinata in potestà patriarcale, sinonimo di potere e di comando e quindi anche di controllo. L’angoscia di John Dutton è quella di venire meno all’impegno non scritto, assunto con chi lo ha preceduto, con la sua famiglia che possiede quel ranch e la sua terra da oltre cento anni. La sua debolezza sta nella drammatica consapevolezza di non sapere o non più poter dare una continuità genetica e non solo economica alla famiglia, perpetuandone nome, ricchezza e potere.

Là dove mantenere il ranch, voleva dire non solo tramandare il legame con la terra, alimentando quello con il passato e con le sue tradizioni, dove ancora dentro ci trovavi la terra, i cavalli e le mandrie. Ma a Dutton, invece sembra proprio mancare proprio la terra sotto i piedi. Il controllo paterno gli sfugge di mano e la ribellione dei figli per riaffermare la propria libertà, con l’arroganza che hanno nell’affermare questa verità, sancisce anche il perduto potere paterno che nella sua forma patriarcale sembra tramontare con l’epopea western. Yellowstone si avvia a diventare una terra senza padri, o di padri putativi, come Rip l’assassino del proprio padre accolto da Dutton quando entrambi erano giovani. Rip sbriga il lavoro sporco, esegue le sentenze di Dutton e non sembra un caso che sia l’uomo di fiducia del padrone, proprio lui assassino del proprio padre. Yellowstone, diretto da Taylor Sheridan, molto attivo in TV, resta un racconto legato caparbiamente e malinconicamente ad un passato irripetibile, scenario quasi esclusivamente maschile, caratteristica che sembra calzare, psicologicamente, anche ai pochi personaggi femminili, duri, spietati e determinati. Beth, l’unica donna del clan dei Dutton, cui dà volto la bella Kelly Reilly, è sicuramente il personaggio più affascinante. È l’unica ad essere capace a prendere in mano il ranch dei Dutton, ma è  anche l’unica a sentirsi lontanissima dal quel mondo. Giocano in questo come sempre i fatti del passato e un presente insoddisfacente. In questa fitta rete di sentimenti si muove il lungo racconto della prima stagione, in attesa di vedere la seconda già girata e la terza annunciata, per completare il tramonto o inaugurare un ciclo che dai reperti del passato dia vita ad un western 2.0 e oltre.
anche l’unica a sentirsi lontanissima dal quel mondo. Giocano in questo come sempre i fatti del passato e un presente insoddisfacente. In questa fitta rete di sentimenti si muove il lungo racconto della prima stagione, in attesa di vedere la seconda già girata e la terza annunciata, per completare il tramonto o inaugurare un ciclo che dai reperti del passato dia vita ad un western 2.0 e oltre.
Dal 19 marzo Yellowstone arriva in prima tv free to air su Paramount Network (sul 27 del digitale terrestre, sul canale 27 di Tivùsat anche in HD e sul 158 di Sky in HD)


